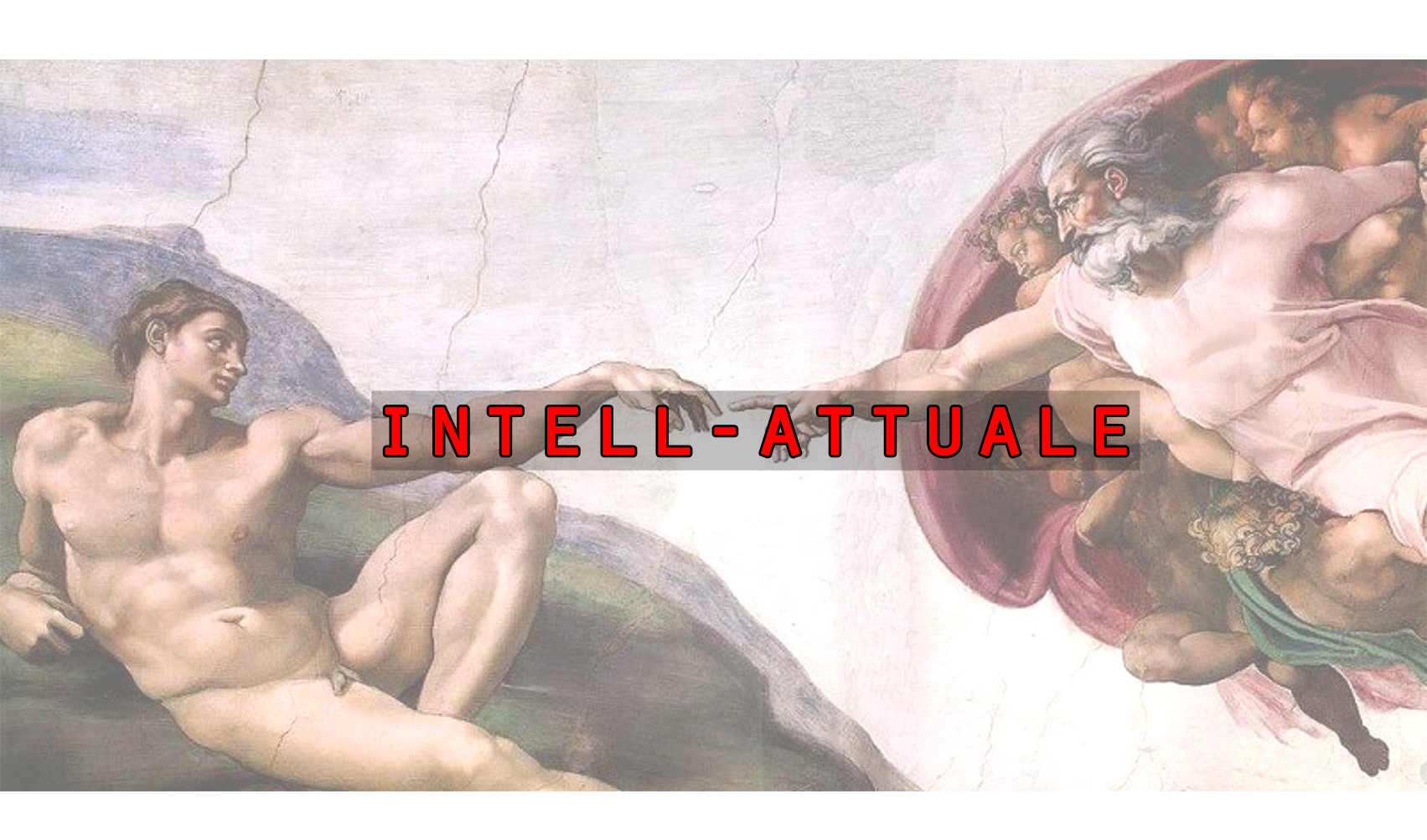La Costituzione nella palude: Indagine su trattati al di sotto di ogni sospetto. Recensione, analisi e commento del libro di Luciano Barra Caracciolo, Imprimatur editore, 2015
LUCIANO BARRA CARACCIOLO: Magistrato – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato – Sottosegretario agli Affari Europei nel Governo Conte.
Capitolo primo. L’Italia e la sua crisi epocale
Dal momento in cui si afferma il vincolo esterno, la democrazia e il benessere in Italia sono entrati in crisi. È stata una manovra oscura, non ben comprensibile, cui si sono prestati tutti i principali media. C’è stato uno strano salto evolutivo nella democrazia italiana; improvvisamente dall’inizio degli anni ’80 cominciano a comparire editoriali, commenti, teorizzazioni che danno per scontata una crisi irreversibile del modello italiano, in contrasto con i dati e gli indicatori economici e fiscali. Si definisce l’Italia un Paese inefficiente, corrotto, incapace di gestire l’interesse generale, quando invece era il Paese industriale di gran lunga più vitale d’Europa. Tutto quello che è stato fatto dopo, dall’entrata nel Sistema Monetario Europeo al famoso “divorzio” del Tesoro dalla Banca d’Italia, ha prodotto gli effetti che sostenevano di voler correggere: crescita della finanziarizzazione, distribuzione della ricchezza solo verso l’alto, aumento della disoccupazione, disincentivo della produttività e degli investimenti cioè deindustrializzazione, progressiva autolimitazione che tuttora ci viene presentata come virtuosa e credibile, ma i cui effetti sono tutt’altro che tali; una storia che ha quasi dell’incredibile.
Il welfare nei Paesi europei è inteso in un modo e in quelli anglosassoni in un altro, due concetti incompatibili. Nei Paesi di democrazia sociale a Costituzione rigida il valore primo, fondamentale e prioritario è il diritto al lavoro, inteso nel senso keynesiano di pieno impiego della forza lavoro, come condizione di equilibrio e di crescita della domanda aggregata; in un senso che oggi non si ha quasi più il coraggio di enunciare. Oppure lo si richiama in maniera del tutto svuotata, nel senso di piena occupazione “naturale”, affermato da Milton Friedman o Robert Lucas, economisti che hanno teorizzato il ritorno a un modello sociale che Karl Popper definisce “capitalismo sfrenato”. Quando si dice “diritto al lavoro” non si prende atto che i mercati e la globalizzazione provocano determinati effetti; si risponde che vorremmo attuarlo ma che non possiamo per mancanza di risorse.
Questa impossibilità di agire, questa mancanza di risorse sono state, però, create intenzionalmente dagli stessi attori che dicono di voler perseguire la piena occupazione in senso neoclassico: la globalizzazione e l’attuale de-regolazione dei mercati sono un fatto istituzionale, cioè scelte che conseguono a posizioni politiche affermatesi essenzialmente nei trattati di precise organizzazioni internazionali che sovrappongono la loro forza “sovranazionale” alle tutele apprestate dalle Costituzioni e di cui predicano l’inattualità: obiettivo che si erano prefisse fin dall’alba di questa ideologia economica. Le politiche di piena occupazione, cioè di sostegno alla domanda e alla crescita, non possono attuarsi senza l’intervento dello Stato. In nessun Paese del mondo e nella storia non si è mai verificato che, se si pone al centro la semplice ottimizzazione di un fattore della produzione, cioè il lavoro assunto come “merce” e rigidamente sottoposto al “mercato”, venisse promossa la crescita armonica, priva di una pericolosa concentrazione verso una vera e propria oligarchia. Applicando queste politiche che depotenziano e sviliscono l’intervento dello Stato, si dimentica che l’obiettivo riguarda anche la dignità e il benessere della società.
La crisi speculativa del settembre 1992 evidenzia le prime avvisaglie della sostanziale inconsistenza della solidarietà tra gli Stati europei, ma il susseguirsi di “tappe” fondative che conducono inesorabilmente all’adozione della moneta unica prosegue inarrestabile ed eventi interni di particolare scalpore mediatico, come “Tangentopoli”, funsero da strumento ad hoc del processo di riassetto politico e sociale ormai unanimemente riconosciuto come “inevitabile”. La classe politica della prima Repubblica offrì quindi un formidabile viatico alla di ri-dislocazione della sovranità dello Stato, cioè del potere decisionale “effettivo” perché “economico”, facendosi mostrare prima funesta e, successivamente, “superflua”. L’Italia, all’uscita dallo SME, non aveva già più le “risorse culturali” per resistere alla reazione neo-liberista delle economie “aperte” e del libero movimento dei capitali. Il dominio della finanza e dei grandi oligopoli capitalistici sovranazionali era stato già evocato e non poteva essere fermato.
E’ lo stesso Draghi, Governatore della BCE, a spiegare come deve funzionare, per necessità scientifico-economica e politica, l’Eurozona. E parte direttamente dalla necessità degli “aggiustamenti” strutturali tra i Paesi membri, evidenziandone le divergenze di crescita e di inflazione, e ponendo in risalto come ciò dia luogo a fenomeni di movimento di capitali che, dai Paesi più competitivi e con tassi di inflazione più bassi, finanziano le importazioni da parte dei Paesi meno competitivi. Racconta, per implicito, come l’invariabilità del cambio favorisca tutto ciò, rendendo conveniente effettuare questo credito da parte dei sistemi bancari dei Paesi più forti. Le posizioni debitorie così create, dovute principalmente a credito privato da scambio commerciale e da affluenza di capitali attratti dai tassi di interesse più alti nei Paesi a inflazione maggiore, divengono di conseguenza eccessive e, quindi, “rischiose”, anche perché tutto ciò “droga” la crescita con il “debito” e genera inflazione. (https://www.youtube.com/watch?v=8TszG75t9p4)
Pertanto, superata questa soglia di “rischio” (visto come probabile incapacità di restituzione) ciò induce i creditori a chiedere il rientro delle proprie posizioni e obbliga i Paesi “deboli” ad agire in un solo modo: effettuare la internal devaluation cioè comprimere la propria domanda interna mediante la leva fiscale (aumento delle tasse e taglio della spesa pubblica), al fine di correggere verso il basso i prezzi, in particolare i salari. Draghi mostra di ritenere tutto ciò un male necessario, e quindi un sacrificio per un presunto “bene” superiore, in quanto non ci sarebbe altra scelta. E lo dice sottolineando che non possono esserci Paesi per sempre (permanent) debitori e Paesi per sempre creditori: fa l’esempio di altre unioni monetarie che contemplano questa possibilità, e la risolvono mediante i TRASFERIMENTI di un comune governo federale verso i Paesi “debitori”, ma esclude che ciò sia praticabile in €UROPA, non essendo realistic allo stato dell’attuale integrazione politica tra gli Stati europei. (https://www.youtube.com/watch?v=LyAcSGuC5zc)
Da quasi dieci anni la crisi economica attanaglia l’Eurozona, impoverita e resa pericolosamente instabile dalla disoccupazione strutturale e dalla svalutazione “interna” del salario. Il mainstream reputa semplicistico affermare che uscendo dall’euro si potrebbero ripercorrere le gesta e riaffermare le conquiste del boom economico; tutta colpa della Cina, della globalizzazione, della finanza, etc. L’euro è indubbiamente un forte catalizzatore di tutte le politiche necessarie per l’affermazione dell’ordine sovranazionale dei mercati. Tutta la disciplina europea che lo accompagna in materia fiscale, sociale, monetaria e bancaria serve a distruggere irreversibilmente la sovranità democratica, mediante incessanti e prolungati STATI DI ECCEZIONE in nome dei “mercati” (la cui proclamazione, come evidenzia Carl Schmitt, indica il vero titolare della sovranità). La stessa sovranità democratica va interpretata come prerogativa dello Stato di decidere e di realizzare gli interessi generali della comunità territoriale che è tenuto ad incarnare, secondo quelle norme fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana rivolte al fine essenziale di promozione dello sviluppo materiale e spirituale di “tutti” gli italiani. Gli stati di eccezione dei mercati, costantemente proclamati in nome dell’€uropa, perseguono interessi e applicano norme che rispondono a obiettivi, al contrario, totalmente avulsi dall’effettivo interesse della comunità nazionale.
Capitolo secondo. La Costituzione democratica del 1948 e la sua difficile sopravvivenza nell’era del neo-liberismo europeista
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il primo gennaio del 1948, delinea uno Stato dove la sovranità appartiene al popolo (art. 1), cioè a tutti i cittadini senza esclusioni e discriminazioni formali o sostanziali, fondato sul riconoscimento del lavoro come più importante espressione della personalità umana: al cittadino, realizzato nel valore sociale della sua attività lavorativa, deve essere consentito di contribuire ai processi decisionali collettivi secondo una parità effettiva costantemente preservata dallo Stato. In ciò si riconosce il principio-cardine della UGUAGLIANZA SOSTANZIALE.
E’ ormai senso comune affermare che la Costituzione sia, in verità, un testo di compromesso, scaturito da una mediazione tra le diverse sensibilità politiche dell’Assemblea Costituente. In realtà, il modello economico che pervade la Carta è palesemente rivolto alla costituzionalizzazione del paradigma keynesiano, concepito come presupposto fondamentale per una compiuta ed effettiva “democrazia”. Federico Caffè, eminente consulente in ambito economico dell’Assemblea, lo precisa in vari scritti, allargando la prospettiva di “interpretazione autentica” alla platea degli intellettuali che, nella prima metà del ‘900, avevano ripensato la democrazia connotandola dell’aggettivo “sociale”, significando la fine della pretesa neutralità dello Stato di fronte al conflitto sociale. Una “neutralità” che dissimulava quella del ruolo dello Stato sotto il profilo economico-fiscale: lo Stato non doveva alterare il naturale prodursi di equilibri allocativi “efficienti” (cioè conservativi dello status quo) e di regole “spontanee” da parte del “libero mercato”.
L’intangibilità di questo dogma, che aveva portato a crisi economiche devastanti e apparentemente irrisolvibili, aveva in particolare determinato la trasformazione delle grandi potenze coloniali europee in Stati autoritari e al servizio di monopoli-oligopoli privati, che reprimevano le istanze sociali con la forza e, successivamente, di fronte all’acuirsi della crisi economica, in Stati che realizzarono diversi tipi di fascismi, utilizzati come ambigue concessioni a qualche rivendicazione di sicurezza sociale, ma sostanzialmente tesi a soffocare, militarmente e poliziescamente, il tentativo popolare di riequilibrio del costo delle crisi economiche, posto ad esclusivo carico della classi più deboli. Guido Carli, nella sue memorie ricostruttive della storia politica economica del dopoguerra, sottolinea però come, poco prima che fosse promulgata la Costituzione, si fosse già stata varata una “costituzione economica” de facto che prescindeva da quella poi costituzionalizzata e che avrebbe controllato e orientato le istituzioni di governo verso una direzione diversa, e più conveniente alle esigenze degli esponenti della classe capitalista del Paese.
In virtù del progredire, quantitativo e qualitativo, delle istanze lavoristiche e sociali sancite dalla Costituzione, la Repubblica Italiana conobbe un’innegabile miglioramento delle condizioni di vita nel corso dei famosi “Trent’anni gloriosi” del miracolo economico (1945-1973) fino ad assurgere al grado di potenza economica ed industriale. Troppi furono, però, i “sabotaggi” e le “ritrosie” nell’attuazione del dettato costituzionale per poter rinvenire un filo coerente che connetta, sul piano istituzionale, il “modo” i cui furono attuate, con lentezza e difficoltà, le politiche keynesiane. Queste, erano considerate, allora, la via al capitalismo “cooperativo” (Eichengreen) ma “sovrano”. Questo tipo di capitalismo, tra Stati sovrani, uniformemente schierati a livello geopolitico, contraddistinse, nell’Europa occidentale, la risposta alla minaccia dei “carri armati di Stalin” in termini di allargamento del benessere economico e, in tal modo, della stessa rilevanza sociale delle classi medie e medio-basse secondo quelle politiche già attuate nel New Deal americano. Di certo, il boom finisce quando si pone in essere con la fine, nel 1963, del primo governo “laburista”, propiziata con una “lettera” della Commissione europea, da poco insediatasi. Un evento che portò all’ interruzione dell’attuazione costituzionale in materia di tutela del lavoro, in una situazione, al tempo, di piena occupazione e, come tale, fortemente temuta sul piano della redistribuzione del potere politico ed economico. Tutto ciò comportò il ritorno a politiche deflazioniste, sul piano monetario e del mercato del lavoro.
Nonostante shock petroliferi, terrorismo e ingerenze esterne, l’Italia dei tormentati anni ‘70 ha comunque indicatori macroeconomici più che rassicuranti. Nel 1977 la disoccupazione era sotto al 7%. E’ in questo contesto che Berlinguer introduce il termine di austerità. L’obiettivo era quello di “consacrare” il PCI come partito di “area di governo”, rassicurando gli USA impegnati nello scontro finale con il blocco sovietico e preoccupati delle conseguenze della fine di Bretton Woods. Una mossa che fu stigmatizzata da Caffè in quanto regressiva in termini di crescita, occupazione e redistribuzione del reddito, in nome di una non ben giustificabile lotta all’inflazione, di cui stranamente non si coglieva più la relazione inversa col livello di occupazione. Il potere d’acquisto delle famiglie va infatti “tutelato”, ma solo in subordine all’esigenza primaria di fornire alla classe lavoratrice un reddito continuativo ed adeguato da sottrarre poi, in seconda battuta, all’ eccessiva erosione inflattiva, tramite i meccanismi di indicizzazione.
Nel 1978 si susseguono il rapimento Moro e le prime tappe dell’adesione allo SME, precursore dell’euro. L’adozione del cambio fisso si perfeziona a distanza di tre anni con il “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro. Il vincolo esterno è una formula principalmente ascrivibile a Guido Carli, unitamente al concetto di statuto della moneta, teorizzato da Ciampi (protagonista del “divorzio” insieme ad Andreatta). La ragione del vincolo esterno è senza equivoci quella di indurre, per via di trattati che ci vincolano ad inseguire (senza mai poterle “raggiungere”, come evidenziò Guarino con riguardo al Trattato di Maastricht) le politiche socio-economiche propugnate dall’ordoliberismo mercantilista tedesco, mediante il controllo whatever it takes dell’inflazione e la stabilità monetaria. Negli stessi anni, Carli, e gli stessi autori del divorzio, affermano che tale vincolo esterno, per quanto non contemplato in alcuna parte della Costituzione, è preordinato allo stesso perseguimento della crescita economica, e quindi del livello di occupazione. Un grande battage mediatico-culturale inizia a propalare la tendenza deflattiva come “bene supremo”, ponendo inevitabilmente in secondo piano gli effetti redistributivi cari ai Costituenti.
Da allora, l’opinione di massa rimane attestata su questa convinzione e non è più in grado di organizzare una resistenza politicamente rilevante, anche per il venire meno del riferimento di una sinistra “socialista” e costituzionalmente orientata: le parole d’ordine dominanti che accompagnano l’evocazione dell’inflazione come “male assoluto” sono l’armamentario anti-Stato che straripa ancora ai nostri giorni. L’inflazione sarebbe causata dall’eccessivo deficit statale e dalla spesa pubblica; quest’ultima, sul piano della “nuova” morale pubblica dominante, è a sua volta portatrice esclusivamente di sprechi e di corruzione. Questi parametri mediatico-politici di lotta all’inflazione e al c.d. ”eccesso” di spesa pubblica al di là di qualsiasi efficienza causale sul ciclo economico effettivamente dimostrata e di una loro rilevazione e misurazione reale, non semplicemente presuntiva e mediaticamente indotta, divengono il nuovo copione del discorso politico. Il tutto viene accuratamente “supportato” da un crescendo di casi mediatici volti a contrassegnare la sfera del “pubblico” come ambito elettivo del malaffare, volti a persuadere inconfutabilmente la massa dei cittadini che solo il privato è bello ed efficiente e che occorra “privatizzare” (“fate presto!”) Le esigenze di attuazione della Costituzione vengono relegate nel dimenticatoio, tanto che questa, fin dai primi anni ’80, viene vista come un residuo storico superato, da sottoporre quanto prima ad una grande “riforma”.
Nel corso degli anni ‘80 l’aumento del debito pubblico, conseguente all’irrigidimento del cambio con l’ingresso nel Sistema Monetario Europeo, lascia presagire gli eventi epocali del decennio successivo: il collasso della partitocrazia, la crisi economica, lo smembramento delle Partecipazioni Statali, la privatizzazione del sistema bancario. Il 7 febbraio 1992, a Maastricht, l’Italia aderisce alla neonata Unione Europea, fautrice di teorie monetariste ed anti-keynesiane radicalmente incompatibili con il dettato costituzionale. Non si registra, però, l’opposizione di alcun attore politico, economico e sindacale. Alle residuali forme di contestazione del processo in atto, e alla critica consapevole della natura strumentale della “costruzione europea” alla restaurazione del neo/ordo-liberismo in nome dell’ordine sovranazionale dei mercati, non fu infatti riconosciuta alcuna possibilità di diffusione presso l’opinione pubblica. Il controllo mediatico “totalitario”, preconizzato da Hayek, cioè il pensiero unico economico, pervasivo di ogni aspetto socioculturale, si erano già consolidato nella precedente decade.
Con l’instaurazione dell’Unione, il vincolo esterno tanto agognato da Carli e Ciampi e precorso dal divorzio Tesoro-Banca d’Italia e dall’ingresso nello SME, diviene realtà: i Trattati Europei “superano” la Costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto. La stessa Corte Costituzionale “glissa” sulle tutele poste a garanzia delle radici “sociali” della Repubblica. Il tutto fondato sull’assunto che dei Trattati di natura “economica” possano incidere sulle sole norme costituzionali relative ai “rapporti economici”, e non su quelle attinenti ai rapporti etico-sociali, politici o sulle stesse libertà civili: come se, disoccupazione, precarietà, deflazione, privazione dell’accesso all’abitazione, un mercato del lavoro esclusivamente regolato sulla competitività nei mercati esteri e politiche di abbattimento della domanda interna basate sulla compressione dei redditi, del risparmio e degli investimenti nazionali, non influissero su quelle condizioni, de facto, preclusive del godimento di quei diritti fondamentali, che la Repubblica si impegna primariamente a rimuovere in base all’art.3, comma 2, della Costituzione voluta dai Padri Costituenti Calamandrei, Ruini, Basso e Caffè.
Recita così un commento di Guido Carli del 1973 sul Rapporto Werner (1971), il primo progetto “ufficiale” di moneta unica delle (allora) Comunità Europee, in merito ai meccanismi automatici di aggiustamento della bilancia dei pagamenti: se in questo momento la lotta all’inflazione appare l’obiettivo prioritario, l’Unione monetaria europea non può tuttavia essere imperniata su un meccanismo che tenda a relegare verso il fondo della scala gli obiettivi dello sviluppo e della piena occupazione, cioè ad invertire le scelte accettate dalla generalità dei popoli e dei governi in questo dopoguerra. Tali meccanismi sarebbero stati una soluzione contraddittoria in quanto collegati all’implicita rinuncia al meccanismo fiscale dei trasferimenti “compensativi”, lasciati a un’indefinita “seconda fase”. Nel frattempo si sarebbero prevista la necessità di aggiustamenti eccessivamente onerosi per i Paesi “debitori” e il concreto impedimento all’introduzione di politiche fiscali anticicliche e di crescita da parte di questi ultimi. Intanto l’utilità, in termini di crescita e di sviluppo, di un’unione monetaria rimaneva in sé indimostrata, quand’anche cioè caratterizzata in partenza dalla perfetta convergenza di indicatori economici (inflazione, produttività, livelli salariali, tutela del lavoro, sistema fiscale, etc.) tra i diversi Stati.
Müller-Armack, l’inventore della formula-simbolo dell’ordoliberismo economia sociale di mercato, già nel 1978 sottolineò come la stabilità monetaria e finanziaria dovesse precedere l’instaurazione di un ordine monetario comune, attraverso la precondizione del pareggio di bilancio nei vari Stati coinvolti. Un nuovo gold standard, tutto interno all’unione monetaria, che avrebbe potuto garantire quella “stabilità”, ovvero quell’attitudine del lavoro, e quindi dei salari e dei diritti dei lavoratori, ad assorbire ogni aggiustamento imposto dal mantenimento della competitività e dell’equilibrio dei conti con l’estero, mediante un alto livello strutturale di disoccupazione e precarietà. Dunque, secondo le teorie economiche condivise dei sostenitori dell’Europa economica e monetaria poi realizzata, le condizioni di stretta convergenza di crescita, ossia inflazione e regime fiscale di pareggio di bilancio, avrebbero dovuto precedere e non seguire l’instaurazione dell’unione monetaria.
Nonostante ciò, si scelse comunque di non percorrere questa via, che pure sarebbe stata, per tradizione culturale, quella preferita dai tedeschi, prima che il neo-liberismo divenisse per loro una pura strumentalità mercantilistica. Il trattato di Maastricht, e prima ancora l’Atto Unico del 1987, videro quindi tutti i “negoziatori” dei Paesi interessati concordi nel creare questa costrizione al pareggio di bilancio e, comunque, alla stabilità monetaria e dunque all’inflazione bassa e stabile, proprio perché, come aveva preconizzato Einaudi negli anni ’40 e negli anni ’50, questo non avrebbe certo portato alla crescita, quanto al ridisegno (anti-)sociale in senso liberista dell’intera Europa. Così Einaudi nel commento al pensiero economico di Erhard e Eucken: O il mercato comune sarà liberista o correrà rischio di cadere nel collettivismo […] anche il qualificativo “sociale” è un semplice riempitivo […] e ha l’ufficio meramente formale di far star zitti politici e pubblicisti iscritti al reparto “agitati sociali”.
In realtà, è proprio la “dimenticanza” di una cultura costituzionale e politico-economica conforme alla Costituzione la base dei nostri problemi. La democrazia costituzionale è stata in gran parte “esautorata”, ma è necessario rendersi conto al più presto che è proprio nella Costituzione la soluzione immediata, e ancora supremamente legale, della crisi italiana. La politica monetaria è, infatti, un pezzo fondamentale della sovranità dello Stato. La sovranità è un potere “originario” di cura di fini generali, accuratamente e esplicitamente prescelti dal potere Costituente, che oggi viene di fatto “usurpato”, in modo implicito se non addirittura occulto, dalle élites autoreferenziali del capitale.
Ecco, quindi, il sorgere del mito della governabilità, con la sua radicale estraneità alla democrazia sostanziale, cioè alla struttura dei rapporti di forza riequilibrata verso il lavoro. Ecco le remote radici del “facciamocome” imitativo delle “grandi democrazie”. Ecco insinuarsi l’individualismo metodologico, il liberoscambismo globale, la de-sovranizzazione statuale e la prevalenza del diritto internazionale privatizzato, intesi come fenomeni quasi indipendenti tra loro, vicende evolutive “ineludibili”, e non come tappe ed epifenomeni realizzativi di un unico grande “disegno”: la Grande Società dell’ordine sovranazionale dei mercati, volta alla restaurazione del paradigma neo-ordo-liberista che vede, nel generare la montante marea dei “perdenti” (disoccupati, pensionati, esclusi, etc.) un risultato della selezione “naturale”, e nel marginalismo “marshalliano” l’unica possibile condizione di equilibrio, in cui le oligarchie riversano, sulla “perfetta” flessibilità del prezzo/costo del lavoro, la loro ossessione per l’efficiente allocazione “paretiana” delle risorse. AD OGNI COSTO! Da qui la condanna senza appello di ogni obiezione ad un progresso imposto come inarrestabile e, quindi, della stessa democrazia “pluriclasse” contrapposta alla “poliarchia” liberal-oligarchica: la democrazia dell’uguaglianza sostanziale “scritta” nella nostra Costituzione POPULISTA.
La sovranità costituzionale del popolo “sovrano”, infatti, trova i suoi fini irrinunciabili nell’articolato della Carta fondamentale, almeno in linea di legittimità ancora vigente, attuale, nonché INDEROGABILE a meno di un “colpo di Stato”. Ma questi fini, per essere stabili e sottratti all’arbitrio mutevole degli interessi economicamente più forti (quelli dei “circoli”) nazionali e internazionali, esige delle regole sottratte al gioco politico-elettorale. In assenza di queste regole “al di sopra” della politica, Calamandrei descrive una politica allo stato libero, dominata da rapporti di forza sociali che, però, tendono a prendere forma sempre nello stesso modo. Chi domina il processo finanziario e di creazione monetaria, chi domina l’allocazione del capitale, automaticamente controlla i media e la cultura. La Costituzione è nata per correggere questa deriva a tutela di una reale democrazia.
L’occasione di costringere, ridisegnare e “ridisciplinare” le masse riottose dei Paesi a Costituzioni “socialiste”, era però troppo allettante: l’adozione di una moneta unica obbliga a deflazionare e a disciplinare le politiche fiscali in senso “austero”, a prescindere da qualsiasi esigenza del ciclo economico, legittimando un sistema di “aggiustamento” dell’ordine sociale rispetto a quello costituzionale. Dunque, si sarebbe offerta, in una cornice di opportuna propaganda mediatica, l’idea della pace e della cooperazione come perno della costruzione europea, ben sapendo che non sarebbe stata altro che una severa disciplina fiscale e del lavoro, chiamando quest’ultimo a pagare il costo degli aggiustamenti automatici, vere e proprie “sanzioni” automatiche, in una visione chiaramente punitiva verso una società eticamente distorta in quella che veniva recepita come la sua deriva “collettivistica” indotta dalle Costituzioni post-belliche.
La conferma di questo percorso ci viene, ancora una volta, dalle memorie di Carli, che indulge in una serie di considerazioni apparentemente contraddittorie: problemi economici e distributivi sarebbero sorti in nome della concorrenza sui liberi mercati, così come tensioni sociali sarebbero state riversate sul lavoro, ma sarebbe stato tutto “tollerabile” sulla base di considerazioni “etiche” collimanti con quelle di Einaudi. Carli oscilla, con un misto di attrazione e repulsione, tra il mito del gold standard e la finale e risolutiva esigenza “etica” di ogni appartenente alla élite liberale di domare gli “istinti animali” della politica e delle plebi italiane. Queste, dunque, avevano bisogno del “vincolo esterno”, costasse quel che costasse. Prosegue Guido Carli: I più intelligenti tra i miei critici di ispirazione comunistica [Caffè, Saraceno, Ardigò, Lombardi, perfino La Malfa…] misero in discussione l’assunto di fondo della nostra politica: il rispetto del vincolo esterno della bilancia dei pagamenti, perseguito attraverso uno sviluppo privilegiato della domanda estera, soddisfatta con esportazioni alle quali era demandato il compito di trainare tutta l’economia. Era il “modello di sviluppo” che l’élite liberale alla quale appartenevo aveva scelto fin dalla fine degli anni Quaranta.
Già in tempi meno “sospetti”, quindi, si era perfettamente consapevoli del fatto che una crescita trainata dalla domanda estera non avrebbe potuto che indurre all’adozione una politica salariale restrittiva e all’attuazione di dinamiche redistributive favorevoli a quei limitati settori industriali sottoposti alla concorrenza internazionale, trascurando la crescita, anche qualitativa, dei settori industriali non ordinati all’esportazione. Un modello basato su un più intenso sviluppo della domanda interna avrebbe consentito una politica salariale più generosa, attuando una redistribuzione del reddito più favorevole alle classi lavoratrici senza nuocere all’equilibrio esterno del Paese. Guido Carli, tuttavia, tiene comunque a rimarcare come, negli anni ’50, l’inserimento dell’Italia nel circuito delle merci, dei capitali e vorrei dire delle idee di un più vasto mercato mondiale ci appariva come una priorità assoluta. L’economia di mercato, mutuata dall’esterno, è sempre stata una conquista precaria, fragile, esposta a continui rigurgiti di mentalità autarchica. Il vincolo esterno ha garantito il mantenimento dell’Italia nella comunità dei Paesi liberi.
La nostra scelta del “vincolo esterno” è una costante che dura fino ad anni recentissimi, e caratterizza anche la presenza della delegazione italiana a Maastricht. Essa nasce sul ceppo di un pessimismo basato sulla convinzione che gli istinti animali della società italiana, lasciati al loro naturale sviluppo, avrebbero portato altrove questo Paese. Parole eloquenti e inequivocabili che indicano priorità e progettualità ben definite contro ogni regola fondamentale della nostra Costituzione. Questo è Maastricht: “sanzioni” automatiche e “aggiustamenti” ad esclusivo carico del lavoro propinati come “benefici” contro il totem ideologico dell’inflazione, quella che Einaudi, nel 1944, giunse a definire la più odiosa delle tasse. Rimane, quindi, inspiegabile come la sinistra italiana (se ancora esiste!) non si sia mai accorta di tutto questo e difenda ancora a spada tratta l’euro, la lotta all’inflazione (invece, al contrario, di combattere la deflazione al netto dei prezzi petroliferi) e come e, soprattutto, perché abbia dimenticato come la Costituzione fosse nata proprio per far sì che tutto questo non potesse mai più ripetersi.
Capitolo terzo. Le radici ideologiche e politico- economiche della costruzione europea. La grande restaurazione neo-liberista: ordoliberismo e modelli di neo-democrazia “idraulica”
Rammentiamo in sintesi la natura strumentale dell’ORDO-LIBERISMO: veste €uro-attuale del neo-liberismo che, imperniata sull’obiettivo del lavoro-merce, prende atto dell’ostacolo delle Costituzioni sociali contemporanee (fondate sul lavoro), ed agisce divenendo “ordinamentale”, cioè impadronendosi delle istituzioni democratiche per portarle gradualmente ad agire in senso invertito rispetto alle previsioni costituzionali.
Questa vicenda di gradualità nell’impossessamento delle istituzioni democratiche, per invertirne la direzione di intervento, cioè per portarle a tutelare e realizzare interessi di segno opposto a quello per cui vennero concepite dalle Costituzioni nate dalla caduta del nazifascimo, riposa su una precisa forma etico-comunicazionale, il “POP”, una precisa fase operativa che ne consente l’attuazione tecnocratica, ed una precisa ideologia economica di tipo restaurativo, come fine ultimo. L’ordoliberalismo, infatti, fin dalla sua genesi, si pone come un tentativo linguisticamente e ideologicamente (nel senso della enunciazione dei valori perseguiti) mirato a rendere accettabile la sostanziale realizzazione (o “rivincita”) del liberismo, cioè del “governo del mercato” sull’intera società; e questo, conservando la facciata del soggetto, lo Stato strutturato (in una molteplicità di funzioni di pubblico interesse), che era visto come la principale interferenza contraria a tale realizzazione.
E’ ovvio che, nella fase del nazifascismo, questa strategia si poté valere, certamente in Germania e, per certi innegabili aspetti in Italia, della coincidenza (transeunte, ma “eticamente” favorevole) dello Stato, avversario tout-court, con quello storicamente manifestatosi nel totalitarismo militarista e guerrafondaio di tale epoca (almeno nei luoghi di nascita dello stesso ordoliberismo). La legittimazione, addirittura “pacifista”, del liberismo compromissorio (nella sola fase iniziale) e strumentale (data la permanente mira alla restaurazione del modello liberista nella sua sostanza integrale), poté quindi godere di un’ambigua investitura “etica” di opposizione al totalitarismo. In effetti, però, l’ordo-liberalismo al totalitarismo non rimproverava affatto la soppressione di quelle libertà “attive” (contro cui si era sempre mobilitato) che contraddistinguevano la democrazia abbattuta dagli stessi totalitarismi: in altri termini, rispetto alla soppressione-negazione (eventuale) dei diritti c.d. sociali (ovvero di tutela del lavoro e del welfare), che erano considerati dai neo-liberisti di ogni “scuola” quali inaccettabili distorsioni del mercato (in particolare e soprattutto, di quello del lavoro), rimaneva in posizione neutra.
Anzi, il versante della critica al nazifascismo, è tutt’ora utilizzato dalla parte liberista più ostinatamente (e strumentalmente) ignara delle reali vicende storiche e dei relativi dati economici: estrapolando le politiche sociali dei totalitarismi come elemento caratterizzante principale (se non unico) degli stessi, propone la mistificatoria equazione tra i totalitarismi e lo stesso Stato democratico pluriclasse improntato al welfare (si tratta del fenomeno dell’ ANTISTATALISMO libertario “liceale”). Nondimeno, questa militanza oppositiva, determinata in ultima analisi dall’insofferenza liberista verso mediatori “politici” estranei all’oligarchia liberista (e la cui stessa esistenza attestava la natura fallimentare della società neo-liberista), consentì ai liberisti di sedersi al tavolo della “ricostruzione” con un’insperata legittimazione.
Tutti i passaggi finora accennati possono trovare, senza grandi sforzi bibliografici, un’agevole conferma sia storica che contenutistica, nelle vicende e nelle biografie che contrassegnarono i protagonisti prima del dopoguerra (ri-costruzione), poi della stessa COSTRUZIONE EUROPEA, nelle sue fasi “comunitarie” e, successivamente “federalunioniste”, sul principale teorico dell’ordoliberismo e della TERZA VIA, cioè di quella che sarà poi la struttura fondamentale del Trattato di Maastricht. Va peraltro precisato che lo stesso Roepke non proponeva la definizione di terza via tra l’economia di mercato e l’economia collettivista: Chiunque tema il rimprovero d’aver ignorato i segnali della storia mondiale si guarderà bene dal parlare ancora di un “sistema misto”, come se ci fosse una terza possibilità, atta a risparmiare la scelta, spesso scomoda, fra economia di mercato e collettivismo quali principi dell’ordine economico.
Ma questa esplicitazione semmai conferma la natura “cosmetica” dell’uso del termine sociale da parte dell’ordo-liberalismo, in quanto strumentalmente agevolativo di una restaurazione del libero mercato tout-court, (senza particolari concessioni che non siano, appunto, la mera aggiunta del termine “sociale”). Curiosamente, a conferma di quanto per questa restaurazione occorra tener conto di esigenze di marketing politico-comunicazionale, elemento principe della strategia di costruzione europea, vediamo come, non casualmente, da parte della sinistra filo-europeista si ponga invece un’enfasi prioritaria sulla “terza via”; e ciò specialmente suggerendo una presunta attenzione “social-lavoristica” di Roepke (ed Einaudi), legata alla sua enunciazione pro-concorrenziale della tutela dei consumatori, legittimati in realtà solo come “produttori” di consumo (glissando sulla loro vera natura di nuovi proletari sempre più precari e sotto-pagati). In qualche modo, politicamente e mediaticamente, si ritiene vantaggioso lasciar vivere l’equivoco che la tutela dei consumatori equivarrebbe ad una più moderna, ed inevitabilmente “nuova”, tutela dei “lavoratori”, laddove questa preoccupazione non aveva alcuna cittadinanza nella visione di Roepke.
E’ importante precisare che l’Ordoliberalismo ha dato di fatto i natali a quella terza via che si imponeva come opzione tra il liberalismo economico e la pianificazione economica, generando quella che è oramai conosciuta come economia sociale di mercato, dove lo Stato dovrebbe assumere esclusivamente un ruolo di regolatore, al fine ultimo di realizzare il “benessere” della società attraverso i punti programmatici fondamentali dell’economia di mercato “sociale”. Questi punti programmatici, tutti rivolti alla sostanziale tutela dello status quo della concentrazione capitalistica dal potenziale emergere di nuovi attori concorrenziali di mercato o di “sconvenienti” fattori di destabilizzazione sociale, nella versione dei padri fondatori dell’ordoliberalismo si possono sintetizzare così:
- un severo ordinamento monetario;
- un credito conforme alle norme di concorrenza;
- la regolamentazione della concorrenza per scongiurare la formazione di monopoli;
- una politica tributaria neutrale rispetto alla concorrenza;
- una politica che eviti sovvenzioni che alterino la concorrenza;
- la protezione dell’ambiente;
- l’ordinamento territoriale;
- la protezione dei consumatori da truffe negli atti d’acquisto.
Si può dunque senza particolare sforzo riconoscere che questi punti fondamentali, non soltanto sono ritrovabili con esattezza quasi compilativa nei trattati sull’Unione Europea, ma, di più, essi hanno la “accortezza” di non parlare direttamente, come appunto gli stessi Trattati, dei riflessi IMMANCABILI che la loro attuazione, in termini di regole dominanti nella società interessata (in pratica, quella dei paesi aderenti all’UE), avrebbe avuto sulla restaurazione del mercato del lavoro perfettamente flessibile che è, poi, in sostanza, l’unica irrinunciabile rivendicazione del liberismo.
Al momento in cui maturarono le condizioni per passare dalla fase difensiva (cioè dalle mere resistenze in sede Costituente e nell’attuazione della Costituzione) alla fase “operativa”, l’ordoliberismo si affidò a uomini come Mitterand, soprattutto, lo stesso Amato e Carli in Italia, Tony Blair, Olof Palme. Adeguandosi ai tempi di una minaccia “comunista” che si andava dissolvendo, fino alla caduta del Muro di Berlino, si registrò sempre più la convergenza della tradizione “cristiano-democratica” con quella “socialista-liberale”, essendo la seconda molto più in grado, per la sua pregressa legittimazione pro-welfare, di far accettare con immediatezza il TINA “thatcheriano” (There Is No Alternative) insito nella restaurazione. Quest’ultima però veniva, ed è tutt’ora, proposta come “nuovo”, reso necessario da una liberalizzazione dei capitali e dei movimenti di forza lavoro e non solo più delle merci, che veniva simultaneamente propugnata e costruita. Sul piano della comunicazione politico-economica, quindi si andava creando una sorta di petizione di principio, euristica: cioè la causazione artificiale e a posteriori, rispetto alla sua stessa enunciazione, della necessità senza alternative che andava giustificando l’affidamento di eccezionali poteri sovranazionali, erosivi delle sovranità nazionali.
Ci sarebbe da interrogarsi sulle mutazioni politico-internazionali che condussero a tale saldatura. L’auto-proposizione dell’ordoliberismo come terza via, (nominale e tattica più che sostanzialmente differente dal liberismo), rese quasi naturale ciò per un processo transitivo di “interpolazione”: se occorreva configurare un’alternativa di riequilibrio tra capitalismo sfrenato, in quanto socialmente inaccettabile nell’evoluzione del conflitto di classe nel corso del ‘900, ed ogni forma di economia pianificata e tendente al “collettivismo” inefficiente, quest’ultimo polo della “triade” compromissoria, via via che si dissolveva, implodendo, il socialismo reale, finì per essere identificato col modello economico-misto delle Costituzioni democratiche del welfare. La costruzione europea attraverso l’ordoliberismo, dunque, come implicano le stesse parole rivelatrici di Amato, si rivelò come occasione di rigenerazione dei partiti socialdemocratici (o riqualificatisi tali) in funzione antitetica al “costituzionalismo”: si considera eticamente correct superare la sovranità costituzionale nazionale in nome della “efficienza” sovranazionale (il vincolo esterno), ed inizia, segnatamente in Italia, la grande stagione della “revisione” delle Costituzioni basate sulla rigidità dei principi sottostanti ai diritti sociali.
In generale, in tutta Europa inizia l’offensiva (OCSE-led) delle “riforme”, variamente proposte come soluzioni parificate ad una grund-norm dinamica addirittura sovra-costituzionale; una proposizione che tende a far dimenticare ogni passato collegamento con il marxismo e che tramuta la sinistra filo-europea da pro-labor a “progressista”, legittimata dunque, dall’idea di “progresso”, a derogare o sospendere l’applicazione dei fondamenti costituzionali del dopoguerra. E sul punto specifico, poi, non esiste un fondamentale dissenso tra, più o meno rivendicate, posizioni ordoliberiste “di sinistra” e posizioni più prettamente “conservatrici”: entrambe condannano la tutela collettiva dei lavoratori, sia che fosse vista come miope perseguimento di “interessi sezionali” forieri addirittura del conflitto tra le Nazioni, sia che fosse, come oggi, sanzionata come principale caso di monopolio “avversario” del funzionamento del “magico” sistema dei prezzi di mercato, tanto più se legittimato dal deprecato riconoscimento normativo dello Stato. Le dispute al riguardo, semmai, confermano che, come in tutte le realizzazioni di un programma politico-ideologico, possono esistere diversi punti di vista sulla miglior via di realizzazione del programma stesso, per lo meno per quanto riguarda la suddetta rivendicazione irrinunciabile.
E che questa realizzazione abbia, per l’Europa, utilizzato come perno la costruzione federalista (salvo poi rinnegarla de facto, ma nel modo tecnico-paludato e mimetico dei trattati), quando si è trattato di realizzare l’altro caposaldo “tattico” ordoliberista, quello della moneta unica, è un fatto storico su cui, il crescendo culminato nei fatti odierni, non dovrebbe lasciare più alcun dubbio. L’ordo-liberismo, quindi, per la sua natura di “compromesso” o terza via (postulata per rendere accettabili i suoi fini ultimi) è uno strumento ideologico-politico più efficace della dura teorizzazione antikeynesiana e “darwinista” sociale di Hayek, perlomeno assunta al suo stato più puro: questi è portato ad ammettere apertamente la preferenza per la dittatura rispetto ad una democrazia (evidentemente “sociale”, cioè pluriclasse e non oligarchica) che ostacoli la Grande Società del mercato.
L’ordoliberismo invece svuota gradualmente dall’interno la democrazia, predicando il riduzionismo idraulico-sanitario della democrazia già definito da Hayek, ma preferendo farlo in una cornice di apparente conservazione del quadro istituzionale, tale da consentire lo svuotamento della democrazia sostanziale (“necessitata”) del secondo dopoguerra, con un’alternanza di gradualità ed accelerazioni sostenute da una forte cornice morale accuratamente proclamata: quest’ultima la fa “assomigliare” all’ordinamento democratico, naturalmente imperniato sui valori solidaristico-umanisti, eliminando così, almeno ad un primo impatto, il senso di minaccia per le comunità sociali coinvolte. Almeno fino a quando la minaccia non sia stata tradotta in un risultato acquisito ed irreversibile. Ma ciò conferma anche il senso dello “stile” della tecnocrazia rivestita da slogan moralistici “pop”, perfettamente incarnato dal famoso brocardo del “capo” della burocrazia di Bruxelles, Jean-Claude Juncker, che riassume in tutta la sua efficienza la tattica politica ordoliberista: Noi prendiamo una decisione in una stanza, poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo di vedere cosa succede. Se non provoca proteste o rivolte, è perché la maggior parte delle persone non ha idea di ciò che è stato deciso; allora noi andiamo avanti passo dopo passo fino al punto di non ritorno.
Voci autorevoli si levano, quindi, a porre in evidenza le finalità ultime perseguite dal federalismo europeo, sottolineando la reale provenienza politico-ideologica del percorso “federativo”:
It was Washington that drove European integration in the late 1940s, and funded it covertly under the Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon administrations […] While irritated at times, the US has relied on the EU ever since as the anchor to American regional interests alongside NATO.
The Schuman Declaration that set the tone of Franco-German reconciliation – and would lead by stages to the European Community – was cooked up by the US Secretary of State Dean Acheson at a meeting in Foggy Bottom. “It all began in Washington” said Robert Schuman’s chief of staff.
It was the Truman administration that browbeat the French to reach a modus vivendi with Germany in the early post-War years, even threatening to cut off US Marshall aid at a furious meeting with recalcitrant French leaders they resisted in September 1950 […]
There were horrible misjudgments along the way, of course. A memo dated June 11, 1965, instructs the vice-president of the European Community to pursue monetary union by stealth, suppressing debate until the “adoption of such proposals would become virtually inescapable“. This was too clever by half, as we can see today from debt-deflation traps and mass unemployment across southern Europe. (https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov)
Certo si sono verificati alcuni “imprevisti” legati perlopiù al “fanatismo ideologico” sopravvenuto da parte europea ma, fino ai giorni nostri, il rapporto costi/benefici in favore degli Stati Uniti è sembrato rimanere positivo e dunque sostenibile oltreoceano:
It is true that America had second thoughts about the EU once Europe’s ideological fanatics gained ascendancy in the late 1980s, recasting the union as a rival superpower with ambitions to challenge and surpass the US. John Kornblum, the State Department’s chief of European affairs in the 1990s, says it was a nightmare trying deal with Brussels. “I ended up totally frustrated. In the areas of military, security and defence, it is totally dysfunctional.” Mr Kornblum argues that the EU “left NATO psychologically” when it tried to set up its own military command structure, and did so with its usual posturing and incompetence. “Both Britain and the West would be in much better shape if Britain was not in the EU” he said. This is interesting but it is a minority view in US policy circles. The frustration with the EU passed when Poland and the first wave of East European states joined the EU in 2004, bringing in a troupe of Atlanticist governments. (https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov)
Il capitalismo disegnato dagli odierni Trattati europei è, quindi, il mondo di Milton Friedman e di Friedrich von Hayek: vi troviamo il libero gioco delle forze di mercato e lo Stato minimo (che deve intervenire solo in presenza dei “fallimenti del mercato”), troviamo la lotta all’inflazione (la cui causa è indicata nell’eccesso di moneta in circolazione e nell’alto costo del lavoro) e quindi la necessità dell’indipendenza della Banca Centrale dai governi, e addirittura la denazionalizzazione della moneta. Che l’obiettivo hayekiano di denazionalizzare la moneta (cioè di sganciare completamente l’emissione di moneta dalle necessità di intervento pubblico dei governi) sia stato conseguito dall’Unione Economica e Monetaria europea non è un rilievo critico, ma una rivendicazione compiaciuta che proviene da Otmar Issing, già capo economista della BCE e membro del suo consiglio di amministrazione: sebbene la via prescelta per ottenere la denazionalizzazione della moneta sia stata molto differente rispetto a quanto reclamato da Hayek, l’obiettivo finale da egli ricercato, cioè la indipendenza monetaria dall’interferenza politica e la stabilità dei prezzi, sono state, a tutti gli effetti, ottenute.
Di conseguenza, ne deriva un modello sociale ed economico basato su valori diametralmente opposti e incompatibili con i valori fondamentali della nostra Costituzione, che può riassumersi nella forma, evidenziata da economisti e scienziati sociali americani e tedeschi, ma “stranamente” assente nel dibattito culturale italiano, del cosiddetto ORDOLIBERISMO. Cioè un tipo di neo-liberismo che, cosciente del consolidamento delle democrazie sociali, programma un progressivo controllo delle stesse istituzioni democratiche per invertire la direzione delle loro azioni verso la comunità dei cittadini. Sembra un’affermazione eccessiva, ma è facile rilevarlo analizzando le esplicite proposizioni teoriche, ideologiche e normative che hanno portato, in progressione, a questa costruzione europea, quantomeno dagli anni ’70, con il problema dell’internazionalismo posto come valore etico “sovranazionale”, ambiguamente proposto in continuità con la democrazia dei diritti fondamentali (sempre, però, più “civili” e meno “sociali”) tutelati dalle Costituzioni nazionali. Un internazionalismo denotato con la locuzione “dell’indistinto”, volto a legittimare l’illusione salvifica del vincolo esterno, concetto introdotto in Italia dagli ambienti bancari e finanziari alla fine degli anni ‘70: una grande “mistificazione” basata sulla pseudo-teoria, strumentalmente auto-denigratoria, che l’Italia non sia capace di autogovernarsi e di promuovere il benessere e la democrazia.
La democrazia sostanziale (cioè il benessere e lo sviluppo collettivo) è semplicemente incompatibile con il governo dei mercati e quello che ne rimane (la versione “idraulica”) è un elaborato filosofico “pop”, che prescinde dai fatti e dissimula il potere di un’oligarchia. Questa, beffardamente e potendo contare impunemente sulla non percezione di fatti ed effetti da parte della “massa”, intende la tanto sbandierata “libertà” (dallo “Statocattivo”) come un simulacro apparentemente accessibile a tutti i “benpensanti” ma, in realtà, a crescente concentrazione in “pochi”. Che divengono poi “pochissimi”. Col consenso entusiasta dei “molti”. Date queste premesse, si propone che il totalitarismo non è altro che la fase assoluta a cui tende il sistema capitalistico liberale, senza freni e limiti, nel momento in cui viene mercificato e monopolisticamente prezzato qualsiasi oggetto sensibile, da qualsiasi risorsa naturale, all’Uomo, dalle norme morali, ai sentimenti. Riferiscono Friedrich e Brzeziński (1956) sul significato storico di TOTALITARISMO, facendo emergere alcuni punti di innegabile contatto con l’ideologia globalista :
a) un’ideologia onnicomprensiva che promette la piena realizzazione dell’umanità (il “MONDIALISMO”);
b) un partito unico di massa, per lo più guidato da un capo, che controlla l’apparato statale e si sovrappone a esso (il partito unico liberale con a capo il Grande Fratello, ossia il Mercato);
c) un monopolio quasi totale degli strumenti della comunicazione di massa;
d) un monopolio quasi totale degli strumenti di coercizione e della violenza armata;
e) un terrore poliziesco esercitato attraverso la costrizione sia fisica sia psicologica, che si abbatte arbitrariamente su intere classi e gruppi della popolazione (gli “autoctoni”, ndr.);
f) una direzione centralizzata dell’economia (il “monopolio” di un mercato massimamente concentrato che pianifica la produzione e fissa i prezzi).
Tutto ciò appare “assurdo” e “delirante” nella sua lapalissiana evidenza. E’ così che, senza alcuna ineluttabile necessità, il potere globalista della “liquidità” di tempo e spazio rende superflue intere categorie di persone, che con la loro semplice presenza disturbano il compimento del progetto totalitario (come le vedove cui sottrarre la pensione di riversibilità, i disoccupati da “sostituire” attraverso l’immigrazione illimitata, i malati da eliminare con l’eutanasia, i maschi “autoctoni” da demonizzare, etc.).
Il Trilemma di Rodrik è sicuramente un potente strumento concettuale che modellizza ciò che dovrebbe essere ovvio ad una persona istruita: ovvero che il diffuso benessere sociale che l’effettività della democrazia comporta, è in contrapposizione con la deregolamentazione del movimento dei capitali che il liberoscambismo impone. Non ci sarebbe nulla da aggiungere, oltre che invitare a studiare la storia dell’economia politica. Il liberista così come lo conosciamo è, infatti, il prodotto coscienziale di un marketing legittimamente promosso e lautamente finanziato dalle grandi oligarchie protagoniste dello sviluppo del capitalismo finanziario. Diffonde quindi proseliti che esulano, perlopiù, dalla scienza economica e, di conseguenza, inevitabilmente votati alla “fallacia” previsionale. Questi è “criminalmente” lucido e razionale, non certo frutto del caso. I monopoli finanziari possono consolidare rendite, quote e potere di mercato attraverso ristrutturazioni sociali efficacissime nei loro effetti “malthusiani” e tutto ciò ha l’utile risvolto aggiuntivo di screditare la professione economica nel suo insieme. Nel “virile” darwinismo globale tanto amato dai liberisti, “giusto” è l’utile del più forte. Va da sé che per lo “squalo” della finanza, forte nel capitale, e per i “moderati”, forti nel numero, lo Stato-nazione, unico “baluardo” dei diritti dei deboli, è Il Male.
Se un’economia di mercato è liberalizzata, è infatti naturale che le divine forze della natura si sfoghino “darwinisticamente”, edificando un nuovo ordine etico e giuridico: in una società capitalistica, la logica propulsiva è quella del profitto e dell’accumulo, ed è legittimo che solo chi controlla una spropositata concentrazione economica possa comprare leggi, morale e creare l’Uomo nuovo a propria immagine e somiglianza; un nuovo Uomo, pronto a servirlo e ad amarlo:
Conviene che le riforme rispettino quanto è possibile le forme esistenti, rinnovando la sostanza. […] I modi sono infiniti, lo scopo è unico ed è di evadersi dalle ideologie democratiche della sovranità della maggioranza. A questa rimanga l’apparenza, ma vada la sostanza ad una élite, poiché è per il meglio oggettivamente. Vilfredo Pareto
Voi inorridite perché vogliamo abolire la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; la proprietà privata esiste proprio per il fatto che per nove decimi non esiste. Dunque voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che presuppone come condizione necessaria la privazione della proprietà dell’enorme maggioranza della società. In una parola, voi ci rimproverate di volere abolire la vostra proprietà. Certo, questo vogliamo. Carlo Marx
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lelio Basso
Già Amartya Sen, sulla falsa riga del teorema dell’impossibilità di Arrow, aveva già dimostrato matematicamente come non fosse possibile realizzare nemmeno teoricamente il dogma del liberalismo classico, che postula indissolubilmente efficienza paretiana del mercato e rispetto delle libertà individuali. Sen dimostra che nessun sistema sociale può contemporaneamente:
a) essere votato ad un senso minimo di libertà;
b) rispettare l’efficienza allocativa così come formulata da Vilfredo Pareto;
c) essere in grado di funzionare in qualsiasi società.
Era perciò matematico che un processo di mondializzazione strutturato sul dogma dell’efficienza allocativa liberista si traducesse nella barbarie della macelleria sociale e dell’inciviltà. D’altronde così è sempre stato. Il Paradosso di Sen, chiamato anche Liberal paradox, è un “paradosso” solo per colui che non conosce la storia: in definitiva non fa altro che, usando gli strumenti dell’economia neoclassica stessa, utilizzare “raffinate” dimostrazioni matematiche per evidenziare che la “libertà” per i liberali classici è sempre e solo quella del mercato. Ossia la propria. Infatti, la struttura che viene imposta con il libero mercato non implica affatto sovrastrutture politiche e giuridiche che possano minimamente essere funzionali a tutelare la libertà dell’individuo. La libertà è una merce come tutte le altre, si vende e si compra. Dani Rodrik estende il non-paradosso alla globalizzazione, sottolineando che solo due su tre delle seguenti proposizioni possono teoricamente realizzarsi con un certo grado di effettività:
(a) costruire una profonda integrazione economica;
(b) lasciare sostanzialmente inalterata la sovranità degli Stati nazionali;
(c) perseguire politiche democratiche.
Infatti:
1) (a & b) → – c : un sistema monetario internazionale con cambi fissi tipo gold standard permette di integrare le economie e preservare formalmente le sovranità nazionali, ma, come dimostrato per l’ennesima volta dall’euro, “quote 90” e monete uniche si rivelano strumenti fascisti di repressione;
2) (b & c) → – a : si rinuncia per l’ennesima volta alla globalizzazione e alla libera circolazione dei capitali, e si torna ai gloriosi anni di Bretton Woods.
3) (a & c) → – b : un federalismo globale kantiano eliminerebbe gli stati nazionali ma preserverebbe la democrazia…solo per la gioia di Hayek e Madison.
Risulta quindi agevole illustrare l’ipotesi per cui la genesi del batterio pop, lo strumento di bassa “manovalanza” del potere liberista che “zombizza” qualsiasi argomentazione fondamentale sull’ordine socio-economico, sia insito nello stesso fenomeno del “liberalismo” (ossia quell’indomita “allergia”, che affligge tanti infantili figli del “benessere”, nei confronti di ogni istituzione umana che possa evocare senso del dovere ed assunzione di responsabilità, in cambio dell’equa affermazione di diritti sociali). Sintetizzando le deduzioni di Sen e Rodick, si può quindi affermare come l’homo politicus non possa essere al contempo:
(a) – democratico;
(b) – liberale;
(c) – statista.
Conclusioni: pseudo-modernità = mondialismo liberale = narcosi atonale: la fine della storia come eterna adolescenza.
Capitolo quarto. Trattati europei e modelli economici globali: l’equilibrio della sotto-occupazione, la finanziarizzazione e la “stagnazione secolare” come effetti istituzionali
Il senso dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana è insito nel modello economico di partecipazione pluriclasse alla crescita, in condizione di pieno impiego, in essa descritto. La Costituzione presuppone che la Repubblica democratica, essendo fondata sul lavoro (art.1), garantisca o tenda a garantire la piena occupazione in senso keynesiano, cioè di utilizzazione più ampia possibile della forza lavoro, considerando la disoccupazione come uno stato residuale che (solo) l’intervento pubblico tende a riassorbire a livelli fisiologici.
Il modello di capitalismo neo-classico di Maastricht e dell’UEM, al contrario, considera la piena occupazione come il risultato di un riequilibrio “naturale” dell’effetto sistemico di domanda e offerta; tale principio incide anche sul “lavoro”, considerato alla stregua di qualunque altro fattore della produzione o merce, e quindi implicando il riequilibrio mediante un’alta flessibilità salariale. Il primo riflesso attuativo di tale impostazione è la progressiva eliminazione per via legale, degli elementi che determinano “rigidità”: prima i meccanismi di indicizzazione salariale e poi, in varie forme, la stessa stabilità della posizione lavorativa, depotenziata attraverso forme di lavoro appunto “instabili” e poi attraverso un nuovo regime di licenziamenti, cioè la flessibilità “in uscita”. L’attuazione ormai prevalente del modello normativo ordoliberista dei trattati europei si concreta, quindi, in un welfare subordinato all’istituzionalizzazione del lavoro-merce.
La piena occupazione sarebbe raggiunta in presenza di qualunque livello di riequilibrio del prezzo del lavoro e il processo implica di vincere le resistenze a tale elasticità mediante un mercato del lavoro normativamente inteso a disattivare i meccanismi che innescano ogni rigidità all’adattamento dei salari verso le esigenze del sistema produttivo. Tutto ciò è, però, normativamente imposto dall’UE, non certo dalla nostra Costituzione. Questo determina fisiologicamente, nel tempo, un grado di disoccupazione stabilmente più elevato, e comunque funzionale a tale obiettivo di piegare le resistenze dei lavoratori ad accettare salari inferiori secondo le esigenze di aggiustamento dettate dalla fluttuazione dei costi delle imprese. Poiché questo riequilibrio, basato sulla considerazione del lavoro come merce esclusivamente soggetta alla legge della domanda-offerta, esige l’eliminazione di ogni elemento di rigidità, si introducono di conseguenza vincoli di bilancio pubblico, in particolare delimitando l’indebitamento fiscale, che si traduce in sostegno alla domanda e, quindi, all’occupazione, generato al di fuori del riequilibrio spontaneo dei costi di produzione. E ciò fino al punto di introdurre il pareggio di bilancio.
In questo contesto la Banca Centrale “indipendente” agisce come garante del lavoro-merce e della minimizzazione dell’intervento costituzionale dello Stato. Questo insieme di misure, previste da rigidi meccanismi automatici e dalla sottrazione agli Stati democratici del potere di emissione della moneta, acutizza lo schema fino a portarlo al livello “ideale” predicato dalla dottrina neo-classica, ma esso trova un complemento indispensabile nell’indipendenza della Banca Centrale, il cui contributo alla flessibilità del lavoro, e quindi alla crescita strutturale della disoccupazione in funzione di flessibilità-deflazione salariale, è meno evidente ma altrettanto efficace. L’affidamento esclusivo del rendimento dei titoli del debito pubblico alle dinamiche del mercato finanziario determina l’innalzamento rapido, e a effetto cumulativo, del costo della stessa spesa pubblica corrente non coperta dalle entrate. Il deficit diviene così un rischio di ulteriore innalzamento di tale costo, instaurandosi una condizione di “pericolo”, strutturale e crescente, di non sostenibilità del debito, in quanto la crescita della ricchezza nazionale può verificarsi a tassi inferiori a quelli dell’incidenza annuale del deficit, per di più inesorabilmente ampliato dal costo cumulato degli interessi.
L’indipendenza della Banca Centrale, quindi, tende a “disciplinare” la spesa pubblica, in quanto il suo aumento deve divenire, in termini reali, più contenuto del tasso di inflazione, per impedire di far dilatare il costo degli interessi (secondo la legge della domanda e dell’offerta in combinazione con lo “sconto” da parte degli investitori finanziari della solvibilità in prospettiva dei titoli emessi a quei rendimenti). Unito poi a “tetti” del deficit, il sistema funziona in termini di progressiva sterilizzazione dell’efficacia di sostegno della spesa pubblica sulla domanda: questa tende a stabilizzarsi sui livelli salariali dettati dalle esigenze di competitività (“esportativa”) del sistema industriale. E cioè sulla produttività che, però, a sua volta, è strettamente correlata al livello di cambio verso l’estero della moneta adottata.
Quindi questa componente della dottrina neo-classica accelera l’instaurazione del sistema in cui il lavoro è, per necessità, solo una merce, che diviene agevolmente sotto-domandata, in coincidenza con l’interagire dei quattro fattori – regime del mercato del lavoro, Banca Centrale indipendente, delimitazioni legalizzate del deficit di bilancio e rigidità del cambio verso monete più forti di quella nazionale. L’intervento pubblico a sostegno dell’economia diviene una mera eventualità, soggetta a rigidi limiti congiunturali, e cioè realizzabile in una (remotamente teorica) fase di espansione che, però, il vincolo di cambio potrebbe non consentire mai, sottraendo stabilmente, in assenza di una rigida politica di contenimento del bilancio dello Stato e salariale, la domanda estera, riassunta nel complesso delle voci che compongono il current account balance, al prodotto nazionale.
La domanda interna perciò tende inesorabilmente a calare (o a ristagnare in termini “reali”) determinandosi un output-gap che può, in situazioni di crisi determinate da fattori esterni, divenire recessione acuita dall’inasprimento pro-ciclico di queste stesse politiche. Queste, formalmente, mirano al deleverage, cioè a ridurre l’indebitamento (del settore pubblico, e immancabilmente incrementando quello del settore privato), ma operano in modo strettamente contabile, ragionieristico – la famosa parodia dell’incubo di un contabile di Keynes, entro lo slogan dello lo Stato è come una famiglia – tralasciando coscientemente di percorrere quel prioritario sistema di solvibilità del debitore che è la sua possibilità di tenuta e di incremento reddituale.
Preso atto, più o meno consapevolmente (a seconda della capacità culturale della forza che abbraccia tale “dottrina”), dell’irreversibilità di questo sistema, si finisce per accedere a un welfare non di sostegno diretto o indiretto dell’occupazione, quale quello previsto in Costituzione: questo prevede la tutela dell’equa retribuzione, art.36 Cost., la positiva valutazione ordinamentale della tutela sindacale, art.39 Cost., la cura dell’istruzione pubblica e della formazione professionale, artt. 33 e 35 Cost., il sostegno pubblico all’elevazione culturale e professionale dei privi di mezzi (art.34, commi 3 e 4), il coordinamento legislativo dell’attività economica PUBBLICA E PRIVATA per indirizzarla a fini sociali (art.41 Cost.), la “adeguatezza” dell’assistenza sociale – e dunque pensionistica – in caso di ogni genere di impedimento della possibilità lavorativa (art.38 Cost.). Tutte previsioni che implicano appunto, con evidenza palmare, non solo il sostegno pubblico diretto o indiretto al livello occupazionale e salariale, ma anche forme che si traducono in un salario indiretto, cioè in mezzi di sostentamento del cittadino/a-lavoratore-trice apprestati dallo Stato in dipendenza di eventi e condizioni non direttamente esplicantisi nel rapporto di lavoro. Ma si tratta appunto di spesa pubblica. E di spesa pubblica programmaticamente assunta dallo Stato come “obbligatoria”, cioè irrinunciabile alla luce dei principi fondamentali (art.1, 2, 3, in particolare secondo comma e 4 Cost.).
In tal senso niente affatto casuale emerge, dall’insieme sistematicamente considerato delle previsioni costituzionali, la SPECIALE PROTEZIONE accordata dalla volontà dei Costituenti al fattore della produzione “lavoro”, una “protezione” intesa come azione politica PRIORITARIA E DOVEROSA PER LO STATO NELLA SUA DIMENSIONE POLITICA E, QUINDI, LEGISLATIVA. Ciò emerge specialmente negli interventi di chi, avendo una profonda comprensione dell’equilibrio macroeconomico – come ad es; come Fanfani, Laconi e, con altri accenti, Ghidini – ha chiara la conseguenza normativa, oggi possiamo dire di LEGALITA’ SUPREMA, di ciò che nel complesso si stava ponendo in atto, ossia l’affermazione del diritto al lavoro come obbligo per lo Stato di perseguire politiche di pieno impiego, collegando questo stesso obbligo, con immediatezza e senza equivoci, agli strumenti di politica economico-industriale dettati nella c.d. Costituzione economica.
Quando, oggi, ci immergiamo nella assolutamente doverosa considerazione della possibile attuazione legislativa dell’art.38 Cost. (se non altro come fondamento di un ambito della legislazione denominato FLEXICURITY o, in un suo frammento suggestivo e non meditatamente proposto, REDDITO DI CITTADINANZA), non possiamo e NON DOBBIAMO, quindi, dimenticare la “pregiudiziale” a questi aspetti, sancita dalla volontà, normativa e vincolante, dei Costituenti: cioè che la precondizione in assenza della cui realizzazione effettiva non si può affrontare il problema “attuativo” di livello “assistenziale” (in senso lato), è il perseguimento del pieno impiego attraverso l’utilizzazione degli strumenti di politica economico-industriale previsti nella Costituzione economica.
Da plurimi interventi dell’On. Moro, cui aderì anche Lelio Basso, vediamo anche come, una volta intrapresa l’attuazione del diritto al lavoro mediante l’azione di sua “tutela” da parte dello Stato, cioè mediante la sua legislazione di protezione e “assicurazione” pubblica, l’altro inscindibile versante della tutela sia affidato, dalla stessa Costituzione, all’autonomia sindacale. Ora, questo ci conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che il diritto del lavoro come politiche statali obbligatorie di pieno impiego, non può trovare attuazione in forme di tutela (della condizione del lavoratore-disoccupato in stato di bisogno) che siano conseguenziali a politiche legislative obiettivamente e strutturalmente contrarie al perseguimento del pieno impiego: cioè in forme di regolazione (statale) del mercato del lavoro che implichino con evidenza la forte limitazione della tutela sindacale che è sancita dalla struttura legislativamente imposta al mercato del lavoro. Cioè, a monte della tutela del lavoro costituzionalmente lecita non può mai esservi una struttura del mercato del lavoro rinunciataria della speciale protezione del lavoro stesso, che ne neghi l’effettività del “diritto”.
Il welfare “adattativo” emerge come saldatura in assenza della priorità costituzionale delle politiche di piena occupazione, con la nostra Costituzione nella palude dell’irreversibilità delle “scelte” sistema €UROpeo. Aderire a un sistema di welfare che si connetta alla accettazione della crescente e strutturata maggior disoccupazione, come nel caso del salario di cittadinanza, da un lato implica la rinuncia a perseguire programmaticamente (sempre nella formale e sostanziale impraticabilità contabile che vincola ad un sacrificio inevitabile all’interno della moneta unica) gli strumenti di sostegno diretto e indiretto del lavoro e della domanda mediante spesa pubblica, dall’altro, assoggetta queste stesse provvidenze, nel quadro in cui vengono assunte, alla clausola, in effetti extra-costituzionale, del limite del deficit o del pareggio di bilancio. Cioè, da un lato si prende semplicemente atto, senza più attribuirvi significato congiunturale da correggere, che il sistema fa della disoccupazione la principale emergenza sociale, rinunciando a rivendicare gli altri strumenti costituzionali intesi a prevenirla, dall’altro, la cura di questa emergenza è perseguita nei limiti dell’accettazione dello schema generale neo-classico: cioè se e in quanto ciò sia compatibile coi tetti del deficit o ancor più col pareggio di bilancio, e quindi col perseguimento del sistema di sterilizzazione dell’intervento pubblico a favore della qualificazione ordinamentale (contraria ai principi della Costituzione) del lavoro come merce.
D’altra parte, anche volendo porre in contestazione tale incompatibilità istituzionale, l’azione delle istituzioni dell’eurozona, già consolidata e sempre incombente, porta a quella situazione di crisi innescabile a piacimento dai “mercati”, che riporta qualunque “ribelle” ai più miti consigli (classico esempio la vicenda “Tsipras”). E dunque, in questo continuo incombere del sovrastante e inderogabile principio della riduzione della spesa pubblica, il nuovo welfare assumerà sempre e solo, nel tempo, il livello che non interferisce col riequilibrio naturale della domanda e dell’offerta: a livelli crescenti di disoccupazione, scontati nell’indebolimento della domanda provocato dall’insieme dei fattori sopra indicati, l’onere, altrimenti crescente, sarebbe considerato comprimibile e riducibile. Il welfare non sarà più un sistema attivo di promozione delle classi sociali subalterne, e in pratica di aumento del benessere generale determinato dalla mobilità sociale, ma una mera valvola di sicurezza per impedire il crollo “eccessivo” della domanda stessa.
La prima rinuncia oggettivamente incostituzionale rimane, comunque, quella alla stabilità e reintegrabilità di un contratto lavoro totalmente flessibilizzato, riducendo il lavoro alla stregua di un qualunque oggetto di contratto di scambio: questo elemento, depotenzia il contraente-lavoratore addirittura rispetto alla normale “parte” degli ordinari contratti di scambio, portando non alla speciale protezione del lavoro, ma al suo opposto: la discriminazione peggiorativa della posizione negoziale del lavoro! Il danno che ha fatto l’economia neoclassica alle scienze sociali, cercando di piegarle a quelle naturali, è pari solo al danno che ha fatto alla democrazia e al sano internazionalismo che questa impone. “Despoti” e “traditori” ci hanno detto chiaro e tondo che il vincolo esterno è necessario per disciplinarci: gli italiani sono plebei irresponsabili, non sanno governarsi, e la democrazia non la meritano…meritano solo la durezza del vivere!
Chi comincia ad avere un po’ più chiari i principi di analisi economica istituzionalista, depurati intenzionalmente dai retaggi ideologici tramite un approccio epistemologico multidisciplinare (ovvero sgomberando in primis tutte quelle sovrastrutture “pop” che non sono altro che falsa coscienza) non tarderà a trovare ulteriori riscontri nell’eterno ritorno della storia umana: L’uso frequente di frasi fatte testimonia infatti una mente incapace di creare qualcosa. […] Una trascuratezza di stile è molto più perdonabile di un’idea confusa. […] La gioventù, cui mancano ancora pensieri propri, cerca di nascondere il suo vuoto mentale dietro uno stile mutevole e luccicante. Non è in ciò la poesia simile alla musica moderna? Allo stesso modo essa diverrà presto la poesia dell’avvenire. Si parlerà con le immagini più strane; si maschereranno pensieri confusi con argomentazioni oscure ma dal suono elevato, in breve si scriveranno opere nello stile di Faust (seconda parte), solo che mancheranno le idee di quella tragedia. Dixi!!!! Friedrich Wilhelm Nietzsche, COME SI DIVENTA CIÒ CHE SI È, 1858.
Tralasciamo il fatto che i grandi architetti della globalizzazione, sempre molto “umani”, auspicano (o, come Attali, “prevedono”) pure una moneta unica alla fine del processo di mondializzazione: siamo avviati in fretta e furia verso un dispotismo tirannico con tutta l’irresponsabilità tipica del mercato monopolistico. Proprio la conclusione a cui è giunto George Orwell recensendo The Road to Serfdom di Hayek: Il professor Hayek ha anche probabilmente ragione nel dire che in questo Paese gli intellettuali hanno un’attitudine mentale più totalitarista rispetto alla gente comune. Ma lui non vede, o non ammette, che un ritorno alla “libera” concorrenza significa per la grande massa di persone una tirannia probabilmente peggiore, perché più irresponsabile, rispetto a quella dello Stato. Il problema con la competizione è che qualcuno la vince. Il professor Hayek nega che il libero capitalismo porti necessariamente al monopolio, ma in pratica è lì che ha condotto, e dal momento che la stragrande maggioranza delle persone preferirebbe di gran lunga una stretta regolamentazione statale ai crolli e alla disoccupazione, la propensione verso il socialismo è destinata a continuare, se l’opinione pubblica ha qualche voce in capitolo.
La letteratura che esiste sull’inconciliabilità tra laissez-faire e libertà individuale (con “libertà” intesa come qualcosa che non sia l’illimitata possibilità del più forte di abbattere il proprio simile impunemente) è sterminata. Sorprendentemente “pop”, a tutti i livelli, è invece la cultura “democratica” contemporanea, dove per democrazia sovrana, al contrario, Calamandrei intendeva quella forma di governo per cui tutti i cittadini concorrono in misura giuridicamente uguale alla formazione della volontà dello Stato che si manifesta nelle leggi e in cui in misura giuridicamente uguale tutti i cittadini partecipano ai diritti e ai doveri che dalle leggi derivano […]. D’altra parte, per aversi uno Stato sovrano ed indipendente è necessario che alla formazione della sua volontà concorrano soltanto, attraverso i congegni costituzionali a ciò preposti, le forze politiche interne: Stato democratico sovrano è quello le cui determinazioni dipendono soltanto dalla volontà collettiva del suo popolo, espressa in modo democratico, e non dalla volontà o da forze esterne, che stiano al di sopra del popolo e al di fuori dello Stato.
Il lemma “democrazia” nel vocabolario filosofico del liberale è un concetto indubbiamente “esoterico”. Secondo Rodrik: le democrazie hanno vari meccanismi per limitare l’autonomia e lo spazio politico dei decisori. Ad esempio, i parlamenti democraticamente eletti spesso delegano il potere a organismi autonomi indipendenti o quasi-indipendenti. Le banche centrali sono spesso indipendenti e ci sono vari altri tipi di pesi e contrappesi nelle democrazie costituzionali. Allo stesso modo, le regole globali possono rendere più facile alle democrazie nazionali il raggiungere gli obiettivi che si prefiggono, anche se queste comportano alcune restrizioni in termini di autonomia. Le regole globali possono migliorare la democrazia controbilanciando i sezionalismi, tutelando i diritti delle minoranze, sia migliorando la qualità delle scelte democratiche.
Questo sarebbe vero nelle situazioni “ottimistiche” come, ad esempio, il caso in cui Il governo del Paese debba affrontare un problema di incoerenza temporale (stando alla teoria dei giochi). Il governo vorrebbe votarsi al libero scambio o al consolidamento fiscale, ma si rende conto che col tempo cederà alle pressioni e devierà da ciò che ex ante è la sua politica ottimale. Così sceglie di legarsi le mani attraverso la disciplina esterna. In questo modo, quando i protezionisti e grandi “spendaccioni” sovranisti (big spender) si presentano alla sua porta, il governo può comodamente replicare: mi dispiace, il WTO ed il FMI non mi permettono di farlo. Questo è palesemente un caso di delega e di disciplina esterna, “paretianamente” efficiente per tutti, tranne che per c.d. “lobbisti” (ossia, in questa accezione, il sindacato!) e per gli interessi “particolari” ed “egoistici” dei lavoratori (ossia dei titolari della vera sovranità democratica).
Ad un esame approfondito ci potremmo rendere conto anche delle distanze siderali che pare ci siano state tra la cultura democratica dei nostri maggiori padri costituenti e quella di chi ha prodotto le Carte costituzionali, anche più moderne, negli altri Paesi. Considerando la tanto decantata costituzione statunitense e cercando nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non troveremmo granché di meglio: anche se per motivi storici diversi, Francia e Germania non sono dotate di una costituzione economica che imponga inderogabilmente un modello di azione di governo di matrice keynesiana, risolvendo il conflitto sociale tramite lo Stato sociale. Né, tantomeno, sono dotate di un “art. 11” che permetterebbe di far fronte comune, in caso si dovesse negoziare a livello internazionale per la risoluzione dei Trattati liberoscambisti. Meglio delle prime costituzioni rigide o di quelle più moderne di stampo ordoliberale è, a questo punto, il modello degli inglesi, che sono privi di una costituzione scritta e hanno, di conseguenza, maggiori margini di discrezionalità. Se una costituzione rigida ha, come nel caso eclatante di quella americana, lo scopo effettivo di proteggere gli interessi delle oligarchie dalle pretese democratiche dei lavoratori, tanto meglio per le classi subalterne non aver vincoli fondamentali che, in ultimo, tutelano gli interessi delle facoltose minoranze.
Capitolo quinto. I trattati europei e il problema di compatibilità costituzionale alla luce dell’art.11 della Costituzione
Il pieno impiego della forza lavoro non è solo un fenomeno di efficienza dell’offerta e della produzione, ma anche di civiltà, dignità, promozione del benessere e della cultura di un popolo. Dal momento in cui, con i Trattati europei, si è accettato di invertire il principio fondamentale del diritto al lavoro, le politiche pubbliche anziché avere come principale obiettivo la piena occupazione, puntano alla stabilità dei prezzi, alla deflazione costante, ad una prevalenza dei “mercati” in chiave di marcata “competitività”. Questi sono i tratti fondamentali degli stessi Trattati europei. Tutto quello che c’è scritto, la pletora di affermazioni, le norme articolatissime e volutamente oscure, tutto quello che c’è intorno si riduce a questo: deflazione e stabilità dei prezzi che finiscono per essere gli unici compiti istituzionali della Banca Centrale Europea.
Nessuna comunità politica può permettersi una situazione del genere non solo perché il mancato intervento pubblico nell’economia e nella società si traduce in un costo sociale, ma perché ne consegue una minore o inesistente crescita. Quando si arriva a situazioni di crisi determinate da fattori esogeni, come quella del 2007-2008, non si hanno più nemmeno i mezzi per uscirne; tutto si avvita in una spirale simile a quella che seguì la crisi del 1929, quando si cercò di curare il calo della domanda con politiche deflattive.
Per come era concepito, fin dall’origine è apparso chiaro, ad economisti del calibro di Wynne Godley, Martin Feldstein e Rudiger Dornbusch, che il modello sociale ed economico dei Trattati avrebbe portato agli stessi problemi del 1929, acuiti dall’adozione di una moneta con effetti simili al gold standard; ed infatti, per i Paesi che l’hanno adottato, l’euro di fatto equivale al gold standard e, come avvenne per questo, li obbliga alle stesse politiche correttive. Il gold standard piace molto ai capitalisti e specialmente a quelli finanziari, perché scarica il costo di qualsiasi crisi ciclica, cui inevitabilmente va incontro il sistema capitalistico, sul lavoro e sui cittadini che sono gli unici a subire il peso delle correzioni proposte come prive di alternativa. Le società capitalistiche di fine ‘800 e primo ‘900 avevano probabilmente una presa molto più salda e autoritaria, tanto che provocarono la reazione marxista.
Di fronte alla brutalità del capitalismo (in certi periodi in America si combattevano i sindacati sparando ad altezza di uomo sugli scioperanti), in altre parti del mondo gli scioperanti si organizzarono per assumere una prassi antitetica, che determinava l’uso della forza in forma di “rivoluzione” della classe lavoratrice. Oggi, l’ordoliberismo e il controllo mediatico rendono più difficile qualsiasi reazione organizzata e portano ad un’insostenibile riedizione del conflitto di classe. Una delle domande che si sono posti i sostenitori dell’ordoliberismo, dopo 30-40 anni di vigenza e consolidamento della Costituzione democratica, redistributiva e pluriclasse, è appunto questa: come far accettare a tutti i cittadini una costante inversione di rotta. Il punto è che, mediante il controllo mediatico, il capitalismo finanziario diffonde una fortissima morale “colpevolizzatrice”, riassumibile in quello che Keynes chiamò l’incubo del contabile, una frase in cui si condensa, dal punto di vista macroeconomico, una vera falsità: AVETE VISSUTO AL DI SOPRA DELLE VOSTRE POSSIBILITÀ.
Le inevitabili accuse di pigrizia rivolte ai lavoratori dei Paesi che non si adeguano con tempestiva efficienza, divenendo debitori e come tali meno “competitivi”, e quelle rivolte alle istituzioni democratiche di essere portatrici di corruzione, frutto di un’attenta falsificazione etica diffusa attraverso fantomatiche “classifiche” dei Paesi virtuosi e competitivi da parte delle stesse organizzazioni internazionali neo-liberiste, sono avanzate da personaggi la cui moralità, dal punto di vista economico e “umanitaristico”, è tutta da verificare. Chang, un economista coreano, tra i più prestigiosi al mondo, che insegna a Cambridge, definisce bad samaritans, cattivi samaritani, quelli che fingono di soccorrere il prossimo ma in realtà vogliono solo “colpevolizzarlo” per imporgli un assetto contrario ai suoi interessi, facendogli accettare, in nome di una persuasione fortemente moralistica, la trasformazione delle istituzioni da strumenti di tutela e rappresentanza del popolo in strumenti destinati a penalizzarlo costantemente. È la fine della democrazia.
Esiste, inoltre, una relazione precisa tra il livello dell’inflazione e quello della disoccupazione; quest’ultimo è inversamente proporzionale al primo: più bassa è l’inflazione, più alta è la disoccupazione. È la famosa legge economica chiamata CURVA DI PHILLIPS, sulla quale si basano quasi tutti i calcoli della nouvelle vague che governa l’Europa. Si ritiene l’inflazione un male in sé in quanto non consente la sicurezza della posizione dei creditori, allocati nel settore bancario: deflazionando, cioè aumentando la disoccupazione e comprimendo i salari, il consumatore capace di risparmio, creato dal modello fordiano del reddito crescente, viene trasformato in un consumatore a debito, per cui il sistema creditizio ha interesse a favorire questa gigantesca trasformazione della società per aumentare i profitti delle banche. E’ così che la grande industria tende a, a sua volta, a “finanziarizzarsi” e, quindi, a mettersi nella stessa posizione e ad intrecciarsi con il potere finanziario.
Questa è un’ulteriore conseguenza, uno dei costi altissimi del modello economico di questo tipo; le crisi del capitalismo nascono essenzialmente da due fenomeni non controllabili al di fuori dell’intervento dello Stato: la tendenza speculativa dal capitale finanziario e la formazione di posizioni di monopolio e di oligopolio. Questi due fenomeni creano squilibrio perché distruggono e accentrano il risparmio, la domanda, il livello del reddito e l’economia reale, cioè i profitti attesi dal sistema produttivo, non quelli speculativi. Questo si sta verificando perché si ha quello che le banche volevano, cioè una situazione deflattiva e un blocco del credito chiamato credit crunch, situazione detta anche, da Keynes, trappola della liquidità in cui, pur in presenza di interessi vicini allo “zero” e di bassa inflazione, nessuno investe, essendosi nel frattempo ridotte sia la domanda di beni, sia conseguentemente l’aspettativa di vendere ciò che si produce. Solo lo Stato può sbloccare la situazione, come sempre fatto dalla crisi del 1929.
Probabilmente non servirà a smuovere la coscienze alterate dei propugnatori del “sogno” €uropeo. Probabilmente non riuscirà ad evitare che, quando si parla di UE e euro (che nell’immaginario politico-mediatico attuale sono non a caso tutt’uno, senza che sia consentita alcuna possibile precisazione o riflessione), si continui a straparlare di “cessioni” di sovranità. Tuttavia, è giusto riportare un intervento tratto dai lavori dell’Assemblea Costituente che testimonia cosa si volesse inequivocabilmente affermare e disciplinare con l’art. 11 della Costituzione. In quella sede, quest’ultimo coincideva originariamente con l’art. 4, che invece sarebbe divenuto la sedes materiae del diritto al lavoro, legando misteriosamente tale numerazione a ciò che l’Unione Europea avrebbe, nella sua realtà storica attuale, comunque negato: e intendiamo sia il legame che vedremo scolpito tra limitazioni della sovranità e perseguimento della pace in condizioni di EGUAGLIANZA E RECIPROCITÀ, sia la dignità del diritto al lavoro come impegno programmatico indeclinabile, anzi prioritario su ogni altro, del plesso governo-parlamento prefigurato nella Costituzione italiana.
Si tratta dell’intervento dell’on. Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione e successivamente del Comitato di redazione. Un intervento quindi altamente significativo e dotato di forza autenticatrice dell’intenzione condivisa del Costituente, pur non esaurendo l’intera gamma delle riflessioni che furono svolte nel formulare e votare l’art. 11: Presidente della Commissione per la Costituzione. Debbo far notare come anche qui aleggia nell’Aula su tutti noi un’ispirazione comune, un’esigenza da tutti sentita di condannare la guerra e di tendere ad una organizzazione internazionale. […] Ecco perché la Commissione propone: «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali». Veniamo alla seconda parte. Accettiamo, invece di «reciprocità» e «uguaglianza», l’espressione «in condizione di parità con gli altri Stati». Non avremmo nessuna difficoltà ad accogliere la proposta Zagari: «favorisce la creazione e lo sviluppo di organizzazioni internazionali». Ma qualcuno ha chiesto: di quali organizzazioni internazionali si tratta? Non si può prescindere dalla indicazione dello scopo. VI POSSONO ESSERE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CONTRARIE ALLA GIUSTIZIA ED ALLA PACE. L’onorevole Zagari ha ragione nel sottolineare che non basta limitare la sovranità nazionale; occorre promuovere, favorire l’ordinamento comune a cui aspira la nuova internazionale dei popoli. […] La questione sollevata dall’onorevole Bastianetto, perché si accenni all’unità europea, non è stata esaminata dalla Commissione. Però, raccogliendo alcune impressioni, ho compreso che non potrebbe avere l’unanimità dei voti. L’aspirazione alla unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno messo in luce che l’Europa è per noi una seconda Patria. È parso però che, anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare anche oltre i confini d’Europa. Limitarsi a tali confini non è opportuno di fronte ad altri continenti, come l’America, che desiderano di partecipare all’organizzazione internazionale. Credo che, se noi vogliamo raggiungere la concordia, possiamo fermarci al testo della Commissione, che, mentre non esclude la formazione di più stretti rapporti nell’ambito europeo, non ne fa un limite ed apre tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i popoli.
Dal discorso emergono alcuni dati essenziali che ci guidano a comprendere la legittimità costituzionale dell’adesione a qualunque organizzazione internazionale:
– che la questione della unione o federazione europea, contrariamente a quanto si lamenta oggi, senza indagare correttamente su quello che i Costituenti espressamente vollero, fu considerata e scartata. Altri interventi furono fatti nel senso di inserire esplicitamente l’Europa come riferimento dell’art. 11, ma, con esplicite argomentazioni e votazioni, fu stabilito di non inserirla;
– la questione delle (mere) limitazioni di sovranità era esclusivamente ed essenzialmente connessa alla promozione della pace e della giustizia tra i popoli, tanto che ci si pose il problema di evitare che potesse connettersi, la (mera) limitazione della sovranità, ad organizzazioni internazionali che non avessero come “scopo” caratterizzante tale giustificazione pacifista. E’, questo, certamente il caso dell’Unione “economica” e, ancor più, “monetaria” europea, in quanto PRIVA DI OGNI RIFERIMENTO AL PERSEGUIMENTO DELLA PACE E DELLA GIUSTIZIA TRA LE NAZIONI. Essa, al contrario, è giuridicamente stratificata e sviluppata solo come un insieme di regole caratterizzate dall’instaurazione di un libero mercato fortemente competitivo che privilegia la stabilità dei prezzi e la piena occupazione ad essa connessa, nei limiti di quanto compatibile con tale stabilità, instaurando la competizione “mercantilista” tra gli Stati coinvolti. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con un’organizzazione che svolge la promozione della pace sia all’interno dei partecipanti sia, collettivamente, verso l’esterno (si pensi alle vicende attuali dell’Est europeo e del Nord Africa);
– che la “cessione” anziché la (mera) “limitazione” della sovranità fosse quanto si voleva escludere, viene confermato dal legame funzionale indissolubile con lo scopo della pace: fuori da esso, neppure la “limitazione” della sovranità ha ingresso nella sfera di liceità costituzionale. E dunque, l’Unione europea è in sé, con i suoi ingombranti, e non ignorabili, caratteri essenziali, un’organizzazione cui sarebbe stato lecito aderire se e solo se non avesse comportato alcuna compressione della sovranità democratica nazionale, neppure una limitazione, figuriamoci una costituzionalmente inammissibile cessione. Per la nostra Carta fondamentale, la “limitazione” è giustificabile solo con lo scopo dell’azione di promozione della pace, intesa come cooperazione che esclude la guerra, ogni forma di ostilità permanente (viatico per la guerra) e l’ingiustizia;
– a ciò va aggiunto che, anche nel caso in cui questo scopo, riconosciuto storicamente e giuridicamente solo nelle Nazioni Unite, entrasse in gioco come caratterizzazione esclusiva giustificatrice, esso avrebbe legittimato la limitazione “funzionale” (cioè soggetta al principio rebus sic stantibus, valida quindi solo nella misura e per il tempo in cui l’organizzazione cui si aderisse perseguisse effettivamente la pace) e soltanto a CONDIZIONI DI PARITA’ con gli altri Stati;
– questa formula è il riassunto delle condizioni, in precedenza proposte all’interno dell’art. 11, della reciprocità (tipica del diritto internazionale) e della eguaglianza: condizioni certamente non rispettate allorché, com’è noto, si impose con il Trattato di Maastricht, il criterio di convergenza del debito pubblico e del connesso indebitamento (deficit), considerando che, come ben sapevano i negoziatori italiani, il costo del debito pubblico italiano, agli inizi degli anni ’90, era oltre il triplo di quello sostenuto dai principali partner del trattato, cioè Francia e Germania, che già allora e poi costantemente non superava il 3% del rispettivo PIL, ponendo così a carico dell’Italia un obbligo limitativo della sovranità non solo, in sé, completamente estraneo al perseguimento della pace ( la quale non costituì, quindi, in alcun modo presupposto dell’ordinamento monetario e fiscale di Maastricht) ma manifestamente e clamorosamente disparitario nonché lesivo del perseguimento degli obblighi programmatici costituzionali relativi ai diritti fondamentali;
– da allora, infatti, mentre la “pace” nelle relazioni internazionali è passata per tutt’altra via che non la Unione europea. Ad attestarlo ci sono la partecipazione italiana e degli Stati europei a tutte le numerose guerre che hanno avuto come teatro i Balcani ed il medio-oriente, connesse all’iniziativa NATO e, talora, anche delle Nazioni Unite;
– la pace “interna” all’Europa degli stessi Stati membri dell’Unione non ha fatto alcun progresso, essendo invece fortemente peggiorate le relazioni di stima e cooperazione, ormai praticamente inesistenti, nell’asfissiante alveo di sprezzanti rapporti “gerarchizzati”, che sono l’esatto contrario della pace e della giustizia fra le Nazioni. Tali rapporti sono infatti sempre più deteriorati dalla necessaria “forzatura” delle regole che ogni organizzazione limitatrice della sovranità porta con sé, in reazione ad una pletora di condizionamenti depressivi dell’economia, improntati alla cruda competizione commerciale reciproca ed alla imposizione di politiche fiscali ed economiche interne nell’esclusivo interesse degli Stati-membri creditori.
Non è certo questa la sede per dimostrare l’ovvio, ossia come la pace nel mondo e nella stessa Europa (intesa non come latenza di scontro politico, commerciale ed addirittura bellico (sempre e ovunque presente, anche quando dissimulato), ma come assenza di una guerra termonucleare globale) sia in realtà da attribuire proprio agli equilibri, a loro volta sempre in bilico, tra gli armamenti e le sfere di influenza territoriali delle super-potenze atomiche. Sta di fatto che, sicuramente, non è certo la cornice offerta dall’Unione Europea a garantire la pace e la giustizia tra le Nazioni all’interno ed al di fuori del continente europeo. Come si può collegare questo alla volontà espressa nella nostra Carta Costituzionale? Semplicemente non si può.
L’USCITA DALL’EURO va anzitutto valutata tenendo conto di un importante principio del nostro ordinamento giuridico, ossia quello della LEX MONETAE, regolato dagli artt. 1277 e seguenti del codice civile. In pratica lo Stato italiano, qualora decidesse di abbandonare l’Euro, potrebbe farlo attraverso un DECRETO LEGGE applicando, nell’interesse nazionale, il principio della Lex Monetae in base al quale, come scrive il Prof. Alberto Bagnai, uno Stato sovrano sceglie liberamente quale valuta usare. Recita l’art. 1277 co. I e II c.c.: I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. Segue l’art. 1278 c.c. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. Ed è proprio qui che trova applicazione un altro dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, ossia lex specialis derogat generali (la norma speciale deroga quella generale). Ce lo spiega ancora molto chiaramente il Prof. Bagnai: Lo Stato ovviamente dovrà, nel decreto di uscita, prevedere una deroga all’art. 1278 c.c. stabilendo che i rapporti di debito e di credito in euro disciplinati dal Codice Civile saranno regolati in nuove lire al cambio previsto alla data del changeover (cioè uno a uno), e non a quella della scadenza del pagamento (che incorporerebbe la svalutazione). (http://goofynomics.blogspot.it/2012/09/a-rata-der-mutuo.html).
Uno scenario completamente differente, comunque, da quello che potrebbe profilarsi nel caso (improbabile) di condivisione europea dei debiti statali attraverso l’adozione di strumenti solidaristici interstatali di matrice fiscale-redistributiva. Come scrive il Prof. Antonio Maria Rinaldi: con la conversione in emissioni comuni (cd. EUROBOND), il debito pubblico si tramuterebbe in giurisdizione internazionale e non sarebbe più convertibile in valuta nazionale in caso di uscita, poiché non risulterebbe più applicabile il principio di Lex Monetae previsto dagli artt. 1277 e 1278 del nostro codice civile. Si tratterebbe dell’abdicazione più totale di qualsiasi residuo di sovranità. (http://www.formiche.net/2014/04/08/ecco-cosa-ci-aspetta-le-elezioni-europee-il-micidiale-erf).
Alcuni sostengono che, se da un lato i Trattati europei prevedono espressamente il diritto di recesso dall’UE da parte di ciascuno degli Stati membri (art. 50 del TUE), dall’altro non contemplano invece la facoltà di recesso dall’unione monetaria. Questo non corrisponde al vero. A parte il fatto che è possibile l’uscita dall’euro per decreto, cioè anche solo attraverso un atto di imperio del Governo italiano, nella veste di un DECRETO LEGGE adottato dall’esecutivo, facendo leva sui casi straordinari di necessità e d’urgenza previsti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., è altresì possibile uscire dall’euro attraverso l’applicazione di due disposizioni normative previste dai Trattati dell’UE, le quali consentirebbero (almeno a livello teorico-giuridico) l’uscita dall’unione monetaria restando nell’UE: trattasi degli articoli 139 e 140 del TFUE.
Tali disposizioni prevedono la distinzione tra Stati la cui moneta è l’euro e Stati in deroga (cioè appartenenti all’UE ma non aderenti alla moneta unica), non escludendo la possibilità per ciascuno degli Stati la cui moneta è l’euro di tornare allo status di Stato in deroga (in tal caso le predette norme andrebbero lette in parallelo con la Convenzione di Vienna). La circostanza di appartenere all’euro è considerata, secondo i Trattati, come premiale e migliorativa rispetto alla mera appartenenza all’UE, tant’è che per aderire all’euro è richiesto a ciascuno Stato, che ne faccia richiesta, il rigoroso rispetto di alcuni parametri economici e finanziari. Ciò detto non si comprende per quale strano meccanismo giuridico uno Stato che ha aderito all’euro (Stati la cui moneta è l’euro) non possa tornare allo status giuridico antecedente all’adesione, essendo sufficiente, perché ciò accada, il mancato rispetto da parte di ciascuno Stato dell’Eurozona di determinati parametri necessari all’adesione o alla permanenza nell’unione monetaria. Del resto, come ha evidenziato il Prof. Giuseppe Guarino, non è possibile, da un punto di vista giuridico, privare un qualsiasi contraente (sia in campo privatistico che pubblicistico) del diritto di recesso: non consentire ad uno Stato la cui moneta è l’euro di tornare allo status antecedente all’adesione rappresenterebbe una gravissima violazione sia del suo ordinamento giuridico che delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Occorre inoltre precisare che un’eventuale uscita dall’euro non significa tornare alla Lira come l’abbiamo conosciuta fino al 2001, bensì adottare una nuova moneta nazionale che, come correttamente sostenuto dal Prof. Claudio Borghi, potrebbe chiamarsi in qualsiasi modo: Nuova Lira, Sesterzio, Fiorino, Scudo, etc… persino Dollaro! Ciò premesso, qualora l’Italia tornasse nella disponibilità della propria sovranità monetaria, dovrebbe anzitutto fissare il tasso di parità della nuova moneta nazionale con l’euro (con rapporto 1:1). Sarà quindi il mercato valutario (l’unico mercato che, per i liberisti, paradossalmente non dovrebbe essere libero!) a stabilire il valore della nuova moneta nazionale rispetto alle altre monete (il cd. “cambio”). La nuova moneta subirebbe certamente (soprattutto rispetto all’euro) una svalutazione che si calcola intorno al 25-30% (vale a dire la stessa percentuale di svalutazione dell’euro sul dollaro avutasi in questi anni per effetto del Quantitave Easing della BCE, senza il verificarsi di quegli scenari apocalittici più volte paventati da giornalisti ed economisti del cd. mainstream), con effetti molto positivi sulle esportazioni e sulla ristrutturazione del mercato interno e dell’apparato produttivo del Paese.
BIBLIOGRAFIA
Andreatta B., Il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia e la lite tra le comari, il Sole 24 Ore, 26 luglio 1991.
Barra Caracciolo L., Euro e (o?) democrazia costituzionale, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2013
Barra Caracciolo L., La Costituzione nella palude. Indagine su trattati al di sotto di ogni sospetto, Imprimatur, 2015
Canfora L., Critica della retorica democratica, Laterza, Roma-Bari, 2002
Carli G., Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari, 1996
Curiel E., La lotta dei comunisti per una democrazia progressiva (gennaio 1945), in Curiel E., Classi e generazioni nel secondo Risorgimento, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1955
De Grauwe P., Secular Stagnation in the Eurozone, voxeu.org, 30 gennaio 2015
Di Maio A., Economia e luoghi comuni. Convenzioni, retorica e riti, ed. L’asino d’oro, 2015
Fusaro D., Pensare altrimenti, Giulio Einaudi editore, 2017
Giacché V., Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa, Reggio Emilia, Imprimatur, 2013
Giacché V., Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, Imprimatur, 2015
Giacché V., La secular stagnation e il fallimento delle politiche di austerity, ideecontroluce.it, 13 marzo 2015.
Hayek, F., Verso la schiavitù (The Road to Serfdom), 1944
Issing O., Hayek – currency competition and European Monetary Union, 1999
Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 – Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
Minsky H., Finance and Stability: the Limits of Capitalism, relazione al convegno The Structure of Capitalism and the Firm in Contemporary Society, Milano 1993
Münchau W., The eurosceptics have the best lines again, Financial Times, 16 luglio 2012
Palma G., UN PIANO GIURIDICO PER USCIRE DALL’EURO, Dossier, lacostituzioneblog.com, 14 febbraio 2017
Rapporto CER, Pacta servata sunt, Aggiornamenti, 25 marzo 2014
Rizzo T.L., Tra i limiti di bilancio europei e i principi ispiratori della Repubblica, Specchio Economico, n. 3, marzo 2014
Ropke W., Etica e mercato: Pensieri liberali, Armando Editore, 2001
Togliatti P., Discorsi alla Costituente, Roma, Editori Riuniti, 1973
FONTI WEB:
goofynomics.blogspot.com – blog di Alberto Bagnai
orizzonte48.blogspot.com – blog di Luciano Barra Caracciolo
www.bankpedia.org
www.formiche.net
www.lintellettualedissidente.it
www.specchioeconomico.com
www.telegraph.co.uk
www.youtube.com

Imprimatur editore, 2015