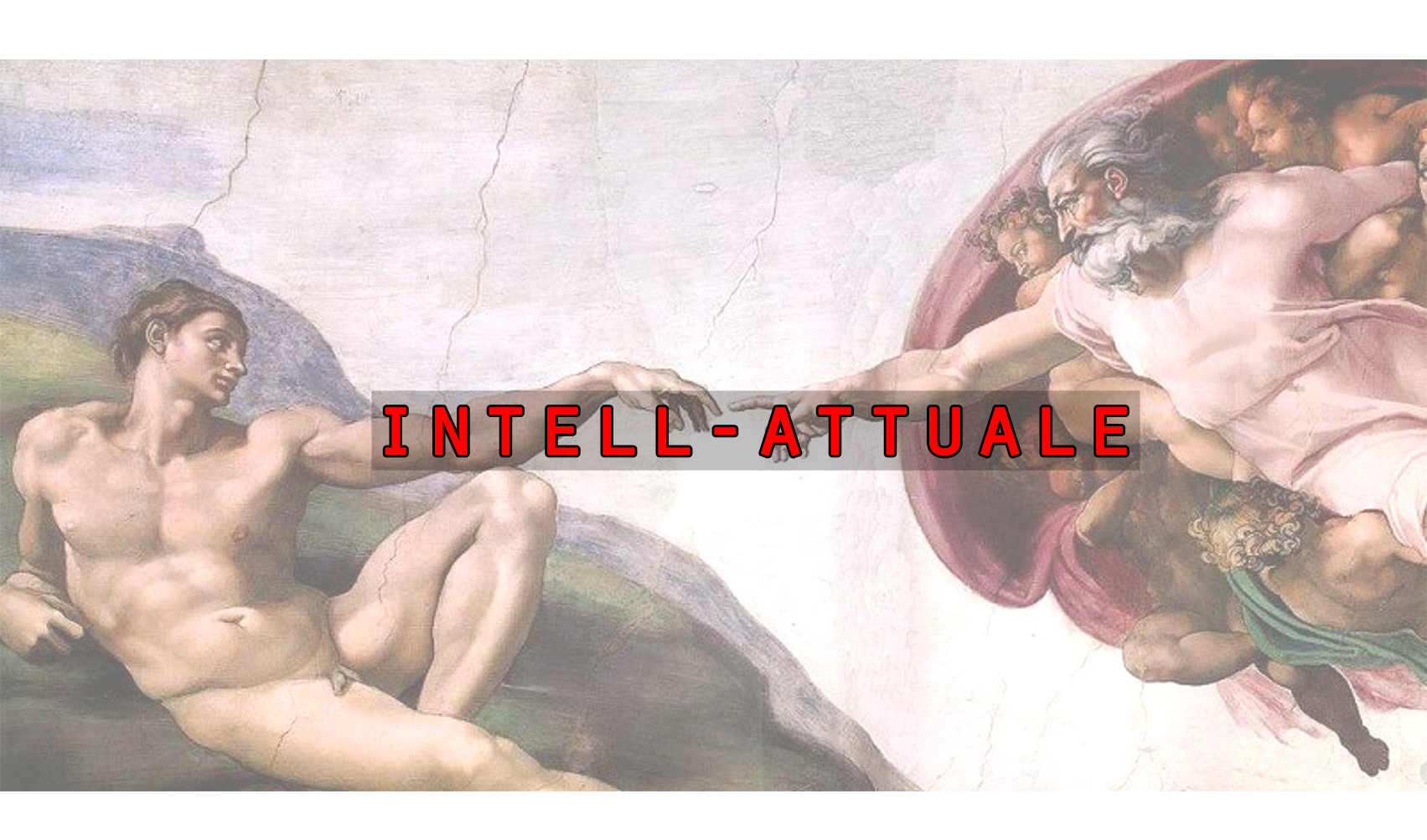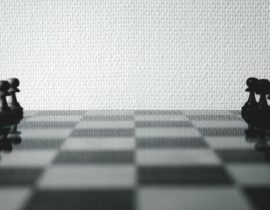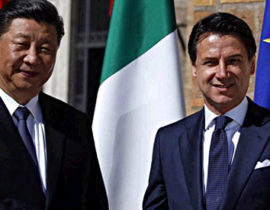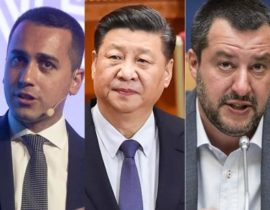L’ITALIA PUÒ FARCELA. Equità, flessibilità e democrazia. Strategie per vivere nella globalizzazione.
Recensione, analisi e commento del libro di Alberto Bagnai, ed. Il Saggiatore, 2014
ALBERTO BAGNAI: Senatore della Repubblica Italiana – XVIII Legislatura – Presidente della VI Commissione (Tesoro e finanze)
Professore associato di Politica Economica presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Ricercatore associato al CREAM presso l’Università di Rouen in Francia e membro del direttivo dell’International Network for Economic Research. Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Asimmetrie Economiche.
INTRODUZIONE
Le politiche di austerity non mirano al risanamento delle finanze statali ma all’artificiosa e repentina compressione della domanda aggregata interna al fine di riallineare i valori della bilancia commerciale, tramite l’abbattimento di quelle quote (aggredibili) di reddito e ricchezza che alimentano le importazioni, e di tutelare i creditori esteri, scongiurando gli esiti inflazionistici che potrebbero intaccare i loro crediti sul piano del valore “reale”.
L’inflazione non è affatto quel male assoluto che si vuol far credere che sia, nell’interesse dei “padroni” del capitale. Sono la stagnazione e la deflazione i veri “mostri” capaci di bloccare l’economia dall’interno: quando i prezzi scendono o non salgono abbastanza, gli attori economici tendono a rinviare spese ed investimenti in attesa di ulteriori ribassi o di un adeguamento dei propri redditi. La Germania affronta oggi una serie crisi demografica, con una popolazione in diminuzione ed in rapido invecchiamento, e la stessa Commissione Europea certifica come il suo sistema pensionistico, presenti già oggi dubbi profili di sostenibilità. Semplicemente, in quanto creditore che vanta cospicui crediti nei confronti degli altri Paesi, la Germania è quindi esclusivamente interessata alla conservazione del valore “reale” della moneta, con una totale avversione per l’inflazione.
La società, dal punto di vista economico, si articola nell’interazione necessariamente “conflittuale” di un complesso di “classi” di persone portatrici di interessi intrinsecamente contrapposti (l’imprenditore, va da sé, desidera pagare il meno possibile il fattore “lavoro”, senza che ciò ne intacchi la produttività). Ma quelle che sembrano essere scelte apparentemente “razionali” nella dimensione individuale e nell’analisi immediata di breve periodo, se non opportunamente coordinate in una più esaustiva e lungimirante visione di insieme, possono rivelarsi disastrose per la collettività, ingenerando “fallimenti di mercato” dannosi per tutti gli attori sociali ed economici.
Il dumping salariale tedesco, prevedendo una forte compressione del livello dei redditi da lavoro ( -6% in quattro anni) dissimulata da politiche statali “sussidiali” in deficit, ha certamente reso i prodotti tedeschi più convenienti sui mercati esteri ma ha anche depresso artificiosamente la domanda interna del Paese, penalizzando le importazioni. Tutto questo ha aggravato la situazione della bilancia commerciale dei Paesi europei e dell’Eurozona, minandone la crescita, la stabilità politica ed economica, il volume della domanda interna e la sostenibilità dell’indebitamento estero, tanto da costringere il resto d’Europa ad importare dalla Germania anche il modello sociale di competitività “ribassista” in termini di retribuzioni e diritti dei lavoratori (con lo sgradevole particolare che il lavoratore sloveno o slovacco certo non parte dalle condizioni di lavoro pregresse di quello tedesco).
Lo stesso Fondo Monetario Internazionale pone ormai in evidenza come, in diverse economie emergenti, la crisi abbia tratto origine da un “aggancio monetario” e la crescita si stata strutturalmente ripristinata solo ad esito dello “sganciamento” dalla valuta estera “forte”, con la reintroduzione di quella flessibilità dei cambi, liberamente definita dal mercato, che consente alle valute nazionali di rispecchiare i fondamentali delle relative economie reali. L’anti-storica introduzione di un sistema di estrema rigidità nel mercato dei cambi, sfociata in Europa nella più antidemocratica delle unioni monetarie, si dimostra da subito esclusivamente funzionale agli interessi del grande capitale, “apolide” più che internazionale (per citare il filosofo D. Fusaro), lasciato così libero di speculare e delocalizzare in un mercato liquido e privo di regolamentazione, nutrendosi della rovina degli Stati nazionali e della classe lavoratrice privati, rispettivamente, della sovranità democratica e dei diritti sociali. Ne consegue che per l’Italia la condizione necessaria, per quanto certamente non sufficiente, per riprendersi da questa crisi apparentemente senza fine sia un’oculata gestione del processo di uscita dall’euro insieme all’introduzione di un nuovo patto sociale tra gli attori economici, lavoratori ed imprese, che renda sostenibile e reciprocamente vantaggiosa la ricomposizione di interessi legittimamente contrapposti.
A tal fine è necessario confutare la falsa narrativa “auto-razzista”, faziosamente promossa dai fautori dello status quo e dei suoi profondi squilibri, che gli italiani siano un popolo “intellettualmente” inferiore, non in grado di governarsi autonomamente. In proposito, enorme è la responsabilità degli attori dell’informazione e degli operatori della cultura nell’aderire ideologicamente ed acriticamente alle posizioni interessate dei potenti del capitale e della finanza internazionale. Proseguendo nell’analisi come proposto anche da altri illustri autori, tra i quali Vladimiro Giacché, è la stessa Costituzione repubblicana ad indicarci la “retta” via: restituire allo Stato la piena e legittima sovranità valutaria, monetaria e fiscale, reinserendo l’esercizio della politica economica nel perimetro di un reale processo democratico. L’optimum è “evolvere” dall’Europa asfittica e tecnocratica del fiscal compact a quella democratica e più equa dell’external compact, cioè muoversi verso un sistema di regole ed istituzioni condivise che, sotto la garanzia della “naturale” flessibilità del cambio, riscrivano il percorso di integrazione europea partendo dalla tutela dei meccanismi di crescita e stabilità dell’economia reale in relazione alla “produttività”, come la giusta tutela del mercato del lavoro e la riduzione degli squilibri nella distribuzione del reddito e della ricchezza.
PROLOGO: L’Italia non può farcela
Per la scienza economica, un’economia è tecnicamente in recessione quando il suo Prodotto Interno Lordo (PIL) diminuisce per due trimestri consecutivi. A partire dal 2011, in seguito alla tanto acclamata “cura” Monti, il nostro Paese ha sopportato una serie consecutiva di ben dodici diminuzioni accertate del PIL, pressoché senza alcun segnale in controtendenza e mai registrata in precedenza, se si esclude il secondo conflitto mondiale.
In generale, negli ultimi 30 anni la potenziale crescita ordinata e sostenibile dell’economia è stata fortemente pregiudicata dal progressivo accrescersi dello squilibrio nella distribuzione del reddito tra i fattori della produzione e dalla grave crisi della domanda e della produttività provocata dal conseguente accrescersi della precarietà e della disuguaglianze.
Gli altri Paesi del “sud” dell’Europa, come Spagna, Portogallo e Grecia, hanno subito la gravità di questa situazione in maniera ancora più accentuata a causa delle loro peculiari vulnerabilità in tema di bilancia commerciale (ad esempio, per lo sviluppo in ambiti di produzione intrinsecamente rivolti più al mercato interno che all’export, come in ambito edilizio), per quanto in alcuni di questi Paesi la produttività (ossia il rapporto prodotto/occupati) appaia paradossalmente in aumento, ma non per il maggior rendimento dei lavoratori o per il progresso nei metodi o nella tecnologia della produzione, ma perché la forza lavoro “superstite” è disposta a sopportare gratuitamente straordinari e turni massacranti (oltre che salari ridotti) pur di non raggiungere i colleghi meno fortunati nelle schiere della disoccupazione.
Siamo quindi al cospetto di un sconvolgimento sistemico di carattere epocale, provocato dalle improvvide e sregolate speculazioni del grande capitale e della finanza transazionale. E’ lo stesso vice-presidente della Banca Centrale Europea (BCE) a riconoscere che nei Paesi il cui debito pubblico è oggi (immotivatamente) sotto attacco, durante i primi anni della moneta unica non c’è stato alcun incremento uniforme dei livelli complessivi di debito […] La rapida crescita del debito pubblico viceversa è cominciata solo dopo la crisi finanziaria […] Le banche europee e i mercati finanziari, nel gestire il rischio di credito, non si sono comportati secondo la teoria.
Gli istituti finanziari, soprattutto nord-europei, hanno commesso impunemente il moral hazard di investire in prodotti finanziari ed erogare credito (soprattutto al consumo) non solo senza una consona valutazione dei rischi, ma nell’opportunistica consapevolezza che la crisi del debito sarebbe stata assorbita da quello Stato “ladro” ed “illiberale” che tanto disprezzano e riversata, di conseguenza, ancora una volta sulla totalità dei cittadini e dei contribuenti.
Per ammissione dello stesso Monti ai microfoni glamour della CNN, l’obiettivo scientificamente perseguito dalle politiche di austerity attuate in Italia, come all’estero, è stato quello di abbattere la domanda aggregata interna e, quindi, di impoverire (irrimediabilmente) il Paese ad esclusivo beneficio della tutela del valore dei crediti esteri.
Il paradosso auto-distruttivo italico si perfeziona grazie all’inverecondo operato di molta parte dell’industria massmediatica nostrana, espressione cooptativa di interessi lobbistici ultra-liberisti “de destra” e di forze ideologiche ultra-liberali “de sinistra”. Questi nemici giurati dello Stato e soprattutto del “popolo” italiano inteso come categoria ontologica ed antropologica, mirano ad utilizzare la tremenda crisi in atto come un’imperdibile occasione per sferrare un attacco definitivo al ruolo dello Stato nell’economia e, quindi, nella società con il taglio di quelle obsolete garanzie “novecentesche” ed illiberali che sono l’istruzione, la previdenza e la sanità pubbliche e con l’asservimento delle residue “vestigia” statali agli esclusivi interessi delle élites finanziarie.
Le armi di questo “martellante” pseudo-giornalismo politicizzato sono la disinformazione e la propaganda denigratoria nei confronti del nostro Paese e dei suoi cittadini (NOI!), con l’individuazione di alcune forzate criticità e, ancor più spesso, l’espressione di pregiudizi e luoghi comuni che, per quanto in alcuni casi estremi non privi di fondamento e di per sé deprecabili, sicuramente non possono essere indicati come connotati generali di un intero popolo (dato che questo sarebbe VERO razzismo!) e, soprattutto, come reali cause della profonda crisi in atto (e questo è ormai pacificamente riconosciuto addirittura dalla letteratura scientifica mainstream):
a) i costi della politica: sicuramente ingenti ma, dati alla mano, nella media europea e di incidenza certamente non tale da provocare lo sconquasso “biblico” dei conti pubblici che normalmente si attribuisce loro, specialmente se paragonati ai miliardi di indebitamento pubblico accumulati a partire dall’inizio della crisi finanziaria per garantire i crediti delle banche estere e mettere in “sicurezza” gli istituti di credito nostrani (in questo caso sì, quelli particolarmente “vicini” a certa politica). Persistono, naturalmente, profili di ordine etico-morale in merito al livello delle indennità e delle agevolazioni di cui godono politici e, soprattutto, alle meritevolezza nella selezione della classe dirigente, con rilievi spesso di ordine penale anche in relazione alle modalità di utilizzo degli ingenti fondi messi a disposizione dell’attività politica di ogni grado, specialmente in considerazione delle difficoltà e delle ristrettezze economiche in cui oggi verte troppa parte della cittadinanza. Rimane comunque innegabile che i cosiddetti “privilegi” della politica esistessero anche molto prima dell’odierna crisi e fossero addirittura maggiori e meno tracciabili e trasparenti di oggi. La riduzione degli “stipendi” dei politici rappresenterebbe, oggi, “solo” una giusta “remunerazione” del demerito di chi, pur ricoprendo ruoli di responsabilità, non solo non ha evitato, ma ha favorito l’insorgere della crisi, cedendo a derive ideologiche ed ad interessi di parte.
b) ‘a coruzzione: un fenomeno deprecabile e foriero di indubbie problematiche sul piano sociale ed economico, con innegabili ricadute “di ritorno” sulla crescita e sull’equità del sistema visto l’effetto distorsivo sull’ottimale allocazione di fattori e risorse altrimenti liberamente definita da un mercato opportunamente regolato. Purtroppo, in modo altrettanto innegabile, la corruzione esisteva anche ben prima della crisi, ed era presente già nel periodo del “miracolo” italiano post-bellico e del benessere degli anni ’60-’80 così come persino ai tempi dell’Impero Romano e della “grande” Germania di ieri e (soprattutto) di oggi, con i suoi torbidi intrighi tra politica, sindacati e multinazionali. E’ quindi alquanto improbabile individuare un rapporto causa-effetto tra i sistemi corruttivi in sé e la crisi economico-finanziaria in atto, tanto più trattandosi di fenomeni più “percepiti” dalla cittadinanza che realmente “registrati”, in quanto ontologicamente “sotterranei” e, di conseguenza, intrinsecamente “inquantificabili”. Inoltre, la scienza dell’economia ci ricorda in maniera inoppugnabile che anche se i fantomatici untori della corruzione si fossero davvero “magnati tutto”, in questo caso specifico, anche il “magnarce” non avrebbe altro che prodotto ulteriore domanda aggregata e risparmio/investimenti (persino quando movimentata esclusivamente estero su estero!). Per quanto sempre innegabilmente condannabile sia sul piano etico-morale che su quello penale, la corruzione non avrebbe mai fattivamente potuto determinare quella che, nei sintomi, è una crisi di finanza pubblica e privata e, nelle cause, è una crisi di bilancia commerciale.
c) l’evasione fiscale: inefficienza ed illegalità non possono mai trovare giustificazione all’interno di uno Stato di Diritto ma, ceteris paribus, in relazione agli “evasori” valgono le stesse considerazioni espresse in merito al fenomeno della corruzione. Lo stesso vice-presidente della BCE sottolinea: La situazione dei conti pubblici si è deteriorata anche a causa di pericolosi effetti di retroazione fra sistema bancario e debito pubblico, emersi DOPO l’inizio della crisi.
La ragione dell’elevato livello del debito pubblico, della spesa pubblica e, conseguentemente, della tassazione in Italia risiede, infatti, altrove in alcuni celebri “divorzi” di ormai unanimemente riconosciuto rilievo storico:
– il “divorzio” del 12 febbraio 1981, tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia, ossia tra Esecutivo e potere “monetario” e quindi tra Governo e Sovranità democratica. La scelta di negare la possibilità del finanziamento monetario del deficit statale, revocando alla Banca d’Italia il ruolo di “prestatore di ultima istanza” nei confronti dell’Esecutivo, con la conseguente necessità da parte di quest’ultimo di rivolgersi esclusivamente ai mercati finanziari privati per il finanziamento della spesa pubblica, giunse nel quadro della liberalizzazione e, ancor più, della progressiva deregolamentazione dei mercati finanziari a livello globale.
– il “divorzio”, consumatosi a partire dalla fine degli anni ’70, tra la crescita dei salari e la crescita della produttività del lavoro, in seguito al quale il ricorso prima al massiccio indebitamento pubblico e, successivamente, a quello privato (soprattutto al “consumo”) si è reso necessario per mantenere stabile il volume della domanda aggregata, realizzando così il “sogno” più oscuro e meno lungimirante dei gradi capitalisti, ossia pagare sempre meno tasse e salari, trasformando a loro volta lo Stato ed i lavorati in debitori. Come se non bastasse, questo “azzardo morale” ha reso poi necessario “salvare” le banche private con ulteriori soldi pubblici e tutelare i creditori stranieri con manovre deflattive “lacrime e sangue” che hanno ulteriormente peggiorato il rapporto deficit/PIL. Dal 2008 al 2014 lo Stato italiano ha dovuto sborsare all’Europa ulteriori 60 miliardi di euro per “salvare” altri Paesi, ossia assorbire il passivo dello loro banche private. E ancora non si era giunti a quella ulteriore ventina di miliardi (trovati in una notte!) per salvaguardare un antico istituto di credito nostrano, a seguito una vicenda non priva di risvolti torbidi e di per sé molto poco “de sinistra” come, invece, molti dei personaggi coinvolti.
Il vero problema quindi, ancora una volta, è la casta politico-mediatica che, invece di osteggiare seriamente il fenomeno della grande evasione, denunciandone i reali e conclamati colpevoli (le multinazionali e la grande finanza, anzi troppo spesso osannate da televisioni e giornali per le “elemosine” volontarie elargite con il nostro Erario in seguito ad “accordi” perlopiù contrari ad ogni logica giuridica e democratica) si ostina ideologicamente ad indicarla come causa primaria della crisi, unicamente allo scopo di fomentare l’odio sociale fra le classi sociali in difficoltà e proseguendo indefessa nel suo pervicace progetto di divide et impera, mirando alla demonizzazione della piccola e media classe imprenditoriale, degli artigiani e delle partite-iva (ossia di coloro che, di fatto, hanno ricostruito e, tutt’ora, mandano avanti questo Paese) che, paradossalmente, sono stati “eletti” ad acerrimi nemici sia dalla sinistra ultra-libertaria (probabilmente per il loro grado di autonomia “di pensiero” e per il loro scarso rilievo nelle “grandi” dinamiche tanto amate dai sindacati) che dalla destra “libberista” (che li vede perlopiù come ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei capitali e, di conseguenza, alla standardizzazione del consumo e dei consumatori). La beffa conclusiva è che, proprio in virtù di questa ignobile oppressione a tutto campo, sempre più piccoli e medi operatori economici sono paradossalmente costretti ad una reale evasione di “sopravvivenza”.
d) la scarsa attrattività per i capitali stranieri: i dati e i fatti, paradossalmente, ci parlano del problema contrario. Troppo made in Italy ha lasciato e continua a lasciare il nostro Paese per arricchire “strutturalmente” lo straniero con le competenze e l’attrattività dei marchi italiani, intaccando così la competitività del sistema-Italia nei confronti dei players esteri ed alimentando, insieme al parallelo fenomeno delle delocalizzazioni produttive, un processo di inesorabile de-industrializzazione della nostra economia, storicamente manifatturiera.
Gli investimenti di capitale straniero a qualsiasi titolo, cioè sia in qualità di investimenti in portafoglio titoli, sia come investimenti diretti nella produzione di beni e servizi (FDI), costituiscono sempre e comunque un debito verso l’estero che, prima o poi, sarà necessario remunerare. Per i Paesi in via di sviluppo l’afflusso di capitali dall’estero è fondamentale al fine di sopperire alle ancora marcate inefficienze del mercato finanziario locale ed è funzionale all’acquisizione di conoscenze tecnico-organizzative e di ricerca-sviluppo. In un Paese avanzato come l’Italia, l’afflusso di capitale estero si sta invece rivelando come una colossale svendita del know-how e degli assets produttivi più pregiati del made in Italy, perlopiù al diretto concorrente francese e tedesco, sull’onda dell’autodenigrazione esterofila alimentata in modo criminale dai media e delle politiche di austerità distruttrici della domanda interna e del PIL. Considerando, inoltre, che l’unico (legittimo) obiettivo dell’investitore è sempre tutelare il capitale investito ed intascarne interessi e profitti, il padrone straniero certo non esiterà a rifarsi su lavoratori sempre più deboli e ricattabili, comprimendone salari e diritti, nel caso ritenga che il suo investimento non stia rendendo nei modi e nei tempi desiderati.
e) i tempi “biblici” della giustizia: sono purtroppo lunghi da sempre e sicuramente lo erano ancora ancora di più negli anni del benessere e del boom economico italiano, quando di certo non esistevano ancora i computer, il processo “telematico” e le moderne modalità di notifica. Fa inoltre sorridere il fatto che l’avere specificatamente a che fare con i nostri giudici possa rientrare tra i primi pensieri di qualsivoglia investitore interessato al nostro Paese. Per quanto si tratti innegabilmente di un fenomeno iniquo ed afflittivo (certamente molto più nei confronti del cittadino comune che in quello delle grandi banche e aziende!) i tempi di risoluzione dei processi in Italia non possono quindi essere annoverati tra le cause della crisi economica in atto. Tra l’altro, la magistratura si limita ad applicare le leggi introdotte o mantenute in vigore dalla politica, sia nello svolgimento delle procedure giudiziarie che nella fruizione delle proprie prerogative e dei propri privilegi.
f) la flessibilità del mercato del lavoro: ovviamente si considera solo “flessibilità” in uscita, cioè la libertà di licenziare, vero significato della parola “riforme” ossessivamente ed unanimemente ripetuta in ogni sede e contesto da ultra-liberali e ultra-liberisti di destra e sinistra. Peccato che, dopo 7 anni di governi neo-liberisti proni al capitale, la libertà di licenziare sia già pressoché totale per il combinato disposto di legge Fornero e Jobs Act “renziano”. Dopo le riforme Treu, Biagi e Giovannini degli anni ’90, il nostro mercato del lavoro era già più flessibile di quello tedesco e francese. Certo, la Spagna ha adottato un sistema ancora più flessibile, ma si può dire, a parità di variabili considerate, che verta in una condizione migliore? La verità oltre l’ideologia ed i vari conflitti di interesse è che, quando l’economia ristagna, la priorità diviene la crescita del fatturato e non la dismissione dei lavoratori. Tra l’altro, il vero imprenditore investe non poco nella formazione e nell’organizzazione della propria forza lavoro ed il basso costo della manodopera emerge come disincentivo per le imprese ad accrescere la propria efficienza, investendo in nuove tecnologie e processi produttivi. In chiave anti-crisi, sarebbe quindi molto più utile, ad esempio, che lo Stato accelerasse i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese private (sopratutto PMI) e ripianasse quanto prima tutti i debiti pregressi.
g) italianibruttiecattivibuh!: la diffusione del falso mito auto-razzista dell’incapacità, dell’inaffidabilità e dell’inferiorità “antropologica” degli italiani è il vero e proprio “crimine” commesso dalle odierne destre ultra-liberiste e dalle (PSEUDO-)sinistre “neo-liberal” attraverso gli organi mediatici di (dis-)informazione di massa nonché per il tramite di vere e proprie schiere servili di arrivisti, autoproclamatisi “intellettuali”. Le élites del capitale finanziario nazionale ed internazionale, infatti, sono pronte a tutto pur di massimizzare il proprio strapotere ed evitare che si verifichi l’unica eventualità che potrebbe veramente mettere a rischio il diabolico piano di distruzione e totale asservimento dello Stato italiano e dell’identità culturale del suo popolo: ossia che gli italiani ricomincino a credere (almeno un po’) in sé stessi…(e nel loro futuro!).
MANUALE DI ILLOGICA EUROPEA (inizio…)
Il progetto di unione monetaria dell’Euro non deve essere (necessariamente) identificato con quello di integrazione europea a livello politico, sociale ed economico. La collocazione geografica dell’Italia sulla propaggine occidentale dell’Eurasia è un dato non umanamente modificabile ed i processi di cooperazione e coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati europei, prima a livello prettamente settoriale (carbone, acciaio, energia atomica, etc.) per poi procedere progressivamente all’instaurazione del mercato comune, sono stati il vero punto di svolta storico per il nostro continente nell’immediato dopoguerra.
L’integrazione, però, deve essere costruita e rafforzata attraverso politiche di crescita e coesione, basate sull’effettiva redistribuzione del reddito e sul rilancio della produttività del lavoro, non sul “ricatto” della moneta in nome di “vincoli” esterni e anti-democratici.
Le vere criticità, acuite se non ingenerate dalla massiccia deregulation e dalle selvagge privatizzazioni inaugurate in tutto l’Occidente dall’era “Thatcher-Reagan”, sono l’inefficienza distruttiva dei mercati finanziari privati e la “favoletta” dell’ottimale allocazione delle risorse intrinseca al sistema capitalistico ed al libero mercato in assenza delle “interferenze” dello Stato “cattivo” e “residuo del passato”. In quest’ottica, è veramente preoccupante che molta della sinistra “proletaria” degli anni ’70 (tra cui si può annoverare l’ex-Presidente Napolitano), che in tempi non sospetti predicava i pericoli derivanti per l’Italia dagli accordi di cambio fisso previsti dello SME, oggi si proponga come imperturbabile paladina di quegli stessi accordi ed invochi a qualsiasi sacrificio (da parte del popolo, naturalmente…) pur di garantire un’unione monetaria ben più rigida di quello stesso Sistema Monetario Europeo che l’ha preceduta.
Un atto di portata storica nel percorso verso la ridefinizione al ribasso della funzione dello Stato in economia, e quindi del significato stesso dei concetti di “sovranità” e “democrazia”, è stata la separazione tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia. In precedenza, quando l’Esecutivo necessitava il reperimento di fondi, si rivolgeva ai mercati finanziari, proponendo Titoli di Stato di diversa tipologia ad un determinato tasso d’interesse. Se gli operatori di mercato non si rivelavano “ricettivi” ed i titoli non andavano completamente venduti, subentrava l’obbligo d’acquisto da parte della Banca d’Italia, che quindi finanziava monetariamente lo Stato italiano emettendo moneta tramite il meccanismo di indebitamento pubblico. Nel 1991, Carlo Azeglio Ciampi svincolò la Banca centrale da tale ruolo e consegnò definitivamente le sorti del finanziamento pubblico nelle mani dei mercati, costringendo il Tesoro ad offrire tassi d’interesse sempre più elevati per assicurare la vendita dei Titoli di Stato.
Gli studi dell’economista della Harvard University K. Featherstone, pubblicati nel 1996, pongono in evidenza come, durante i negoziati per la firma del trattato di Maastricht, si fosse registrato un coinvolgimento minimo da parte dei rappresentanti dei ministeri italiani nei lavori preparatori e le scelte politiche di maggior rilievo fossero state palesemente influenzate dalle istanze di una piccola élite tecnocratica fortemente decisa ad imporre al nostro Paese una disciplina economica “vincolista”, stabilita dall’estero, incentrata sull’imposizione “esterna” di riforme ribassiste in materia di mercato del lavoro interno (diritti, salari, pensioni, etc.) e della sempre maggiore deregolamentazione del comparto finanziario (perché ce lo chiede l’Europa!).
Nell’ambito della politica monetaria, non esiste un optimum tecnico relativo al tasso d’inflazione. L’inflazione è una variabile squisitamente politica, perciò adattiva, connessa alla massa monetaria e, quindi, di carattere prettamente “endogeno”, ossia dipendente dallo stato in cui verte l’economia. I reali meccanismi di definizione della massa monetaria, infatti, sono perlopiù estranei allo spettro decisionale delle autorità di politica monetaria. La moneta, in sostanza, “nasce” con l’erogazione del credito da parte degli operatori del settore bancario ed il livello totale della moneta circolante è quindi profondamente connesso con la propensione, l’opportunità e l’interesse, da parte di questi ultimi, a concedere prestiti ai privati piuttosto che investire o speculare su altro. E considerando che la moneta si “crea” quando le banche erogano un muto o un finanziamento, e ciò avviene solo quando è plausibile che il debitore sia in grado di onorare il proprio impegno in virtù delle garanzie che riesce ad offrire, la moneta viene “prodotta” solo se il clima economico è stabile e positivo. Ne consegue che la massa monetaria è solo in minima parte “esogena”, cioè definita da decisioni di carattere politico o tecnico che siano prese da operatori esterni o sovraordinati al sistema economico.
Il volume complessivo della moneta cartacea “stampata” nell’intera zona-Euro, ammonta a 935 miliardi, ossia appena ad un decimo dei 10.016 miliardi di euro di moneta “bancaria” o “elettronica”. Eppure nei talk-show “liberali” e sulle pagine dei giornali “progressisti” si critica sempre più quello che sembrava essere il vizietto dello Stato italiano “sprecone” di “stampare” moneta sonante…
Inoltre, il vero problema non è tanto rappresentato dal fenomeno dell’inflazione in sé (che anzi, se opportunamente gestito, può rappresentare un efficace meccanismo di redistribuzione del reddito all’interno del sistema economico nonché un sintomo della crescita economica stessa), quanto dal calo del “potere d’acquisto”, ossia dal fatto che le retribuzioni diminuiscano, non crescano o crescano ad un tasso inferiore rispetto a quello di inflazione (perché non “indicizzati”).
Gli accordi valutari dello SME prevedevano un sistema di cambi fissi, ma “aggiustabili”. I Paesi cioè individuavano un livello di “parità” e si impegnavano a preservarla, ma nell’eventualità di squilibri nei fondamentali economici era possibile concordare un “riallineamento” dei tassi di cambio.
I dati dimostrano incontrovertibilmente che il surplus commerciale italiano si attestava ai livelli di quello della Germania, in costanza di un regime dei cambi “flessibile” realmente espressivo della forza relativa delle economie dei singoli Paesi. Poi è subentrata la moneta unica a pregiudicare gli equilibri nell’Eurozona e, di conseguenza, in tutto il mondo sino a destare le preoccupazioni di Cina e, soprattutto, Stati Uniti. Il surplus tedesco, già nel 2014, si attestava a 237 miliardi e ha continuato a crescere fino a far guadagnare alla Germania la “medaglia” di maggior esportatore netto mondiale, nonostante e anche grazie alla crisi e ai suoi effetti sulla deindustrializzazione e sul ricorso all’indebitamento privato, particolarmente acuti nei Paesi “mediterranei” dell’Euro.
Di fatto, l’euro non è servito ad inibire il “vizietto” italico di svalutare, ma ha impedito ai tedeschi di rivalutare, garantendo alla Germania i benefici di un “marco” ingiustificatamente sottodimensionato. La Germania sta sempre più lacerando l’Eurozona con il suo inarrestabile delirio mercantilista dissimulando, tramite un vero e proprio neo-colonialismo economico nei confronti dei propri cosiddetti “partners” europei, pulsioni espansionistiche probabilmente mai sopite e destinate all’eterno ritorno della Storia.
Così come inevitabile, a questo punto, diviene il confronto con gli Stati Uniti d’America, che non a caso tentano di reagire all’aggressività commerciale tedesca “ingabbiando” l’intera Unione nel TTIP, il trattato di libero scambio che, in caso di entrata in vigore, trasformerebbe definitivamente l’intera Europa in una nuova zona paludosa a sud del Mississippi, travolgendone peculiarità e presunti vantaggi competitivi. E’ quindi comunque innegabile che sia tanto infondato quanto improvvido attribuire alla Germania il ruolo honoris causa di locomotiva d’Europa: è chi acquista i prodotti altrui, non chi vende (tra l’altro forzatamente) i propri, a spingere la crescita dell’economia mondiale. I tempi del piano Marshall sono trascorsi da tempo e gli Stati Uniti cominciano a trovare sconveniente il fatto di continuare a rivestire in solitudine il ruolo di traino del benessere altrui, considerando che allo scopo si rende necessario adottare misure espansive di politica economica che nel lungo periodo potrebbero ritorcersi contro la loro stessa economia.
MANUALE DI ILLOGICA EUROPEA (…fine)
La creazione della moneta unica era fondata sulla fideistica certezza che all’interno del sistema non sarebbero mai emersi problemi di scompenso della bilancia dei pagamenti fra Paesi creditori e debitori. Al contrario, l’adozione dell’euro avrebbe rimosso costi e tempi di transazione dando un impulso esponenziale alla domanda. Seguendo il dogma dell’infallibilità del mercato, si affermava che sarebbe stato sufficiente attribuire ai singoli Stati la funzione di rispondere (eventualmente) a shock nazionali e regionali attraverso i meccanismi del welfare e altre politiche, lasciando alle sempre meno regolamentate dinamiche finanziarie il compito di trasferire efficientemente fondi e risorse all’interno della nuova area monetaria integrata, senza che si concepisse l’esigenza di istituire un bilancio “europeo” di carattere federale che compensasse o almeno attutisse le conseguenze dirette ed indirette delle anomale situazioni di surplus e deficit della bilancia dei pagamenti sui sempre più fragili budget statali.
E’ ormai quasi superfluo ricordare come la situazione sia evoluta in tutt’altra direzione e certo non abbia tenuto fede alle stesse previsioni del trattato dell’Unione Europea che, per quanto stridenti in molti altri termini e principi con il dettato stesso della Costituzione Italiana in materia economica, almeno statuisce che l’Unione dovrebbe essere basata su una crescita economica equilibrata […] e su un’economia sociale di mercato. Era infatti noto, sin dagli albori del trattato di Maastricht, che il rischio risiedeva nel comportamento sregolato ed imprudente dei mercati finanziari privati che, come già previsto, hanno determinato l’accumulo di volumi insostenibili di indebitamento estero all’interno dell’Eurozona, poi assorbiti dai bilanci pubblici dei singoli Stati chiamati a risolvere le crisi bancarie del nord Europa, ossia a spendere miliardi di ulteriore debito pubblico per mantenere in vita il proprio creditore affinché poi quest’ultimo, da vero “ingrato”, venisse a sua volta a “battere cassa”.
Il concetto stesso di “federalismo” implica la presenza di un’autorità sovranazionale, finanziariamente autonoma in quanto dotata di un proprio bilancio e, di conseguenza, preposta ad erogare i necessari trasferimenti compensativi nei confronti degli Stati federati. Ma per gli “euristi” una simile autorità non serve, il mercato è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Fin dagli esordi l’Europa degli esclusivi interessi del capitale ha escluso la via politica della solidarietà tra Stati, predicando convergenza e “selezione naturale” senza alcuna integrazione. Ne costituisce un esempio palese il tanto discusso “sussidio di disoccupazione europeo”, rigettato dai Paesi più “forti” (ma in realtà solo più “agevolati” da regole di favore scritte a colpi di “lobbismo”) nell’autoalimentata convinzione della propria superiorità morale ed antropologica. Per i fanatici della moneta unica europea è, infatti, “irrilevante” che (pur volendo per il momento soprassedere sulla valutazione della reale utilità economica e della coerenza “storica” del voler intraprendere, ancora al giorno d’oggi, il processo di creazione di un super-Stato europeo) rebus sic stantibus la sua mancata realizzazione ingeneri, di fatto, tutte le crisi in corso nell’Eurozona dato che una moneta non può esistere senza uno Stato. Gli squilibri di competitività indotti dal forzoso regime di cambio fisso inducono gli Stati più “deboli” ad indebitarsi per fronteggiare i propri deficit di bilancio sempre più strutturali e, in assenza di un’autorità federale che possa garantirne il rifinanziamento, l’unica prospettiva plausibile è un completo collasso del sistema economico che, molto presto, potrebbe finire per ripercuotersi anche sui suoi veri responsabili.
Viene naturale chiedersi come sia possibile che, nell’ambito di una simile visione dogmatica incentrata sull’inamovibile fede nell’intrinseca efficienza dei mercati, i tecnocrati dell’ultra-liberismo e della deregulation “selvaggia” si siano prefissati come obiettivo prioritario proprio l’abolizione del mercato dei cambi. Non si può certo affermare di riporre la propria assoluta fiducia nella presunta capacità del sistema capitalistico di domanda e offerta di allocare sempre correttamente le risorse tramite il meccanismo di definizione dei prezzi, quando non si vuole affatto consentire che il valore o il disvalore sistemico dell’economia di un Paese venga espresso e giunga all’attenzione dei mercati internazionali attraverso le oscillazioni del prezzo della sua moneta.
A questo si aggiunga che l’unione monetaria offre oggi ai Paesi membri (e ai loro privati cittadini) la possibilità di indebitarsi a tassi d’interesse che non riflettono il reale rating creditizio del Paese.
Inoltre, per quanto ci si ostini a credere nel valore, più “esoterico” che scientifico, di livelli percentuali degli indicatori economici non corroborati da alcuna evidenza, neppure statistica [come i fantomatici valori deficit/PIL al <3% e debito/PIL al <60% contemplati dal “patto di stabilità e crescita” (PSC)], nessuna teoria economica ha mai stabilito un livello ottimale per il valore dei rapporti tra indebitamento, debito e PIL, con la sola eccezione della ricerca di due economisti di Harvard poi rivelatasi basata su un banale errore di utilizzo del foglio di calcolo elettronico.
La verità raccontata dai fatti è che l’euro, ossia la moneta unica avrebbe dovuto “educare” al rigore i “frivoli” Paesi sud-europei, ha invece agevolato ed incentivato il ricorso agli strumenti di indebitamento, affievolendo sia nel creditore che nel debitore la percezione dei relativi rischi.
L’instaurazione di un mercato unico, incentrato sulla libera circolazione di capitali, merci ed individui consentita dall’abolizione delle barriere interne all’UE tra i singoli Paesi, non necessita affatto dell’adozione una moneta unica. L’euro, al contrario, si sta rivelando sempre più un ostacolo insormontabile alla sostenibilità e, quindi, alla sopravvivenza stessa dell’Unione. Il mercato unico europeo, non a caso, è in vigore dal 1957, da ben prima dell’introduzione dell’euro.
L’unione monetaria è sostenibile solo in presenza di un’autorità sovranazionale abilitata a sopperire agli squilibri sistemici e a fornire soluzioni condivise ma differenziate ai singoli Paesi membri, di carattere monetario o fiscale, a seconda delle esigenze espresse dalle loro economie e certamente non “procicliche”, ossia peggiorative, come le politiche di austerità durante una crisi. In vigenza di un’unione valutaria, è infatti necessario che i singoli Paesi siano “sincroni” nelle rispettive fasi di recessione/espansione. Una politica monetaria comune, infatti, non permette alle singole economie in difficoltà di ricorrere autonomamente a quegli strumenti di politica economica che gli permetterebbero di tornare a crescere, al di fuori dell’improbabile ipotesi in cui quella stessa Germania, i cui persino i singoli Lander federati si rifiutano categoricamente di sostenersi a vicenda, decidesse di finanziare a proprie spese la ripresa economica dei vicini europei.
Con buona pace di coloro che pensano che il vero talento degli italiani sia solo quello di fare i “bagnini” e che il ruolo futuro dell’Italia sia solo quello di vendere pasta e gelato ai turisti (per la maggiore pensionati tedeschi!) è, infine, opportuno riflettere sull’utilità e sull’opportunità, da parte di ciascun Paese, di specializzarsi unicamente nei settori in cui si ritiene (o si viene indotti a pensare) di avere un vantaggio competitivo, con il serio rischio di esporsi ad imprevedibili shock sistemici esterni, ad esempio connessi all’elasticità della domanda estera o alle materie prime. Come se anche la metalmeccanica e la meccatronica non fossero praticamente da sempre un campo di eccellenza del Made in Italy ed il modello stesso dei distretti produttivi delle PMI italiane non fosse da tempo studiato e a sua volta “esportato” in tutto il mondo, anche quando producono solo ciabatte!
VIVERE AL DI SOPRA DEI PROPRI MEZZI
La “favola” del capitalismo narra che chi partecipa al processo produttivo viene remunerato in modo proporzionale alla propria produttività e, di conseguenza, tutti ottengono quanto meritano. L’imprenditore massimizza il proprio profitto intervenendo sulla “quantità” di lavoro utilizzato, cioè sul fattore variabile della produzione, nel momento in cui il valore della produttività marginale dell’ultimo lavoratore assunto, ossia della quantità aggiuntiva di prodotto che si ricava dal suo contributo alla produzione, coincide con il “salario”, ossia con il costo dello stesso lavoratore. Non c’è quindi alcunché di anomalo nella profonda crisi del sistema capitalistico che stiamo ancora oggigiorno vivendo, per la seconda volta in meno di 100 anni. Sono, infatti, ormai più di 30 anni che il capitalismo non mantiene le sue stesse promesse e che, in realtà, i nostri mezzi “vivono” al di sotto di noi.
L’attuale crisi finanziaria trae origine proprio dalla patria del capitalismo contemporaneo, ossia gli Stati Uniti. I dati dimostrano come l’andamento dei redditi da lavoro non segua affatto il trend della produttività ormai a far data dal 1971. I salari ristagnano e declinano da più di 40 anni al contrario della produttività, alimentando così l’aggravarsi delle diseguaglianze sociali, e per di più non registrando alcun rilevante mutamento di prospettiva in corrispondenza dei diversi indirizzi politici espressi nel tempo dalla Casa Bianca. Il rapporto tra il livello dei salari e quello della produttività del lavoro è noto alla scienza economica: il decennio tra il 1919 ed il 1929, nel quale la crescita della produttività superò del 3% quella dei salari, si concluse con la Grande Depressione. Gli anni tra il 1971 ed il 2008, con lo stesso valore del rapporto, hanno prodotto la crisi attuale.
Per il proprio funzionamento, Il sistema capitalistico necessita infatti di un adeguato livello della domanda aggregata, ossia che il reddito prodotto venga equamente distribuito tra coloro che concorrono al processo produttivo, affinché questi possano acquistare gli stessi beni e servizi che contribuiscono a generare. Al contrario, a partire dalla fine degli ’70, i lavoratori hanno visto comprimersi il potere d’acquisto dei propri salari, e si è reso quindi necessario finanziarie la domanda aggregata attraverso l’indebitamento, prima pubblico e successivamente privato.
Il concetto chiave della visione filosofica del fordismo, secondo il quale gli operai sono i primi clienti dell’imprenditore e, quindi, quest’ultimo dovrebbe avere tutto l’interesse pagare loro buoni salari, è stato di fatto superato da un altro, secondo cui gli operai, se sottopagati, diventano i primi debitori dell’imprenditore, che così ha l’occasione di guadagnarci due volte.
Le “speculazioni” finanziarie, i mercati virtuali, gli algoritmi ed i bot capaci di compiere miliardi di transazioni al secondo, incredibilmente, sono solo una minima parte del problema, per lo più rilevante nel contesto della generale deregolamentazione dei movimenti di capitale e spesso agitata dai media conniventi solo come diversivo affinché l’opinione pubblica non si concentri sul punto critico dello scontro di classe cui ha ormai condotto più di un quarantennio di mancata od iniqua redistribuzione del reddito e della ricchezza prodotti dal sistema.
Le uniche “riforme” che possono garantire la tenuta dell’economia e garantirne la ripresa, sono gli interventi legislativi di politica sociale ed economica che permettano di transitare da un sistema dominato e schiacciato dal debito ad un’economia guidata dai salari, innescando nuovi meccanismi di equa distribuzione e tutela del reddito da lavoro in rapporto all’inflazione e alla crescente produttività.
Con l’abbattimento del muro di Berlino e la dissoluzione del blocco sovietico orientale, il capitalismo ha perso qualsiasi freno inibitorio, non avendo più nemici esterni ed alternative da screditare, teoriche e o reali che fossero. I dati dimostrano come la progressiva compressione dei diritti sociali e dei salari dei lavoratori segua la caduta dell’impero comunista russo più che l’ascesa della Cina, “spauracchio” tanto decantato dal mainstream quanto di per sé assai recente e, di conseguenza, di certo non determinante nei confronti di fenomeni risalenti già alla fine del secolo scorso. In realtà, sono proprio la crisi e la successiva implosione dell’Unione Sovietica ad aver fatto sì che si rompessero gli indugi in quel processo, tutto “thatcheriano”, trovatosi quindi senza più alternative (T.I.N.A. = There is no alternative). Sono queste le radici dell’odierno neo-liberismo, che vuole la trasformazione di ogni lavoratore da cliente a debitore dell’imprenditore e che considera lo Stato come il nuovo nemico da smembrare e sottomettere all’esclusivo interesse del capitale finanziario.
Alle intrinseche criticità di questo contesto, sia aggiunga il ruolo di “violatori seriali” dei vincoli europei ricoperto da francesi e, soprattutto, dai tedeschi. La Germania, con l’avvio dell’Agenda 2010 delle riforme Hartz, ha sforato il fatidico parametro del 3% stabilito dai Trattati ed aumentato notevolmente il debito pubblico, sussidiando in deficit con incentivi e finanziamenti la propria industria e le politiche “attive” per il mercato del lavoro, l’istruzione e l’edilizia popolare, nel quadro generale di dimezzamento delle tasse per le imprese, svalutazione “interna” dei salari in termini reali (del 6% tra il 2003 ed il 2009) e liberalizzazione sfrenata dei contratti di lavoro con riduzione delle tutele sindacali, sotto la minaccia di licenziamenti e delocalizzazioni e sfruttando il ricatto degli alti livelli di disoccupazione all’8%-10%. Il tutto propugnato dal Governo social-democratico di Gerhard Schröder: si sa, quando il grembiule del carnefice è “rosso”, gli schizzi di sangue della classe lavoratrice si notano meno. E la Francia, con Hollande, non ha certo potuto permettersi di essere da meno: la Francia ha un forte problema di competitività, che si traduce in un saldo negativo e decrescente delle partite correnti (cioè in un crescente indebitamento estero), e quindi, non potendo svalutare rispetto ai suoi principali partner, dovrà praticare la cosiddetta “svalutazione interna”: rimozione delle garanzie sindacali, tagli dei salari…(A. Bagnai, 7/5/12 www.libreidee.org).
Le ripercussioni macroeconomiche di questo assetto non hanno certo tardato a manifestarsi nei “virtuosi” Paesi del Nord, traducendosi in una profonda crisi demografica, un grave deficit infrastrutturale nei trasporti, un sistema pensionistico insostenibile ed un sistema finanziario privato sull’orlo della bancarotta. Una volta strappato il “velo di Maya” della propaganda che tanta sponda trova nei fautori dell’auto-razzismo anti-italiano, la stessa Germania si rivela per quello che è: un Paese in cui Governi che si professavano di “sinistra” hanno esplicitamente scelto di privare i lavoratori dei benefici della loro stessa produttività, comprimendo salari e diritti in favore del profitto, per abbattere il benessere generale della popolazione e, di conseguenza, le importazioni ed al fine di promuovere esclusivamente le esportazioni, “aggredendo” con inaudito impeto mercantilista i mercati di tutti i vicini europei. Una lotta di classe senza quartiere dove i padroni del capitale mirano ad incrementare a dismisura i propri profitti disinnescando le tensioni inflazionistiche che potrebbero intaccare i loro crediti. E per far questo si avvalgono proprio dei degli esponenti di quelle forze politiche e sindacali da cui ci si aspetterebbe azione volte a tutelare e promuovere le prerogative delle classi lavoratrici. Gli stessi carnefici dal grembiulino “rosso” che oggi “sbandierano” l’arma definitiva del dumping sociale avverso la residua tenuta dei salari e contro quel che ancora rimane dell’identità linguistico-culturale dei popoli europei (recepita come causa della scarsa mobilità del lavoro tra i Paesi europei, in un’interpretazione naturalmente “di parte” dell’opera di J. Meade) dopo decenni di propaganda programmatica basata sulla demonizzazione delle frontiere, ossia dell’ultimo baluardo a protezione dei diritti dei lavoratori contro la liquidità del globalismo: l’immigrazionismo di massa.
Peccato che lo stesso Mario Draghi abbia affermato a Helsinki nel novembre 2014: una più grande mobilità internazionale del lavoro è benvenuta, ma la ricerca suggerisce che è improbabile che i flussi migratori della forza lavoro diventeranno mai la chiave per l’aggiustamento del mercato del lavoro. E ad ogni modo nessun Paese prospererà se la sua popolazione lo abbandona. Il Mezzogiorno d’Italia si accinge a diventare un deserto (“africano”). Tacito scriverebbe: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, ossia dove facevano il deserto, lo chiamavano pace.
APPELLISTI CONTRO AUSTERIANI
La scelta delle parole è importante. Ogni volta che una parola connotata positivamente in termini emotivi viene utilizzata in un dibattito nel quale dovrebbe prevalere la razionalità, la manipolazione è all’opera, e il disastro incombe. Il “sogno” europeo e l’“austerità” sono due ottimi esempi (e il secondo è ampiamente una conseguenza del primo). La favoletta morale suggerita dal termine “austerità” è semplice: la crisi con la quale conviviamo da anni sarebbe stata causata dalla prodigalità dello Stato ladro. La medicina amara dell’austerità, somministrata da tecnocrati virtuosi, è l’unico rimedio per simili eccessi del passato. Inutile dirlo, questa favola è sembrata plausibile a quelli che Keynes chiama “the ordinary unistructed person”, e che noi forse chiameremmo l’uomo della strada, o la società “civile”. Tutti siamo chiamati a pagare le imposte, e molti reagiscono considerando lo Stato come un nemico. Una favola in cui il cattivo è un tuo nemico indubbiamente è seducente. Tuttavia, non per questo rispecchierà la realtà. (A. Bagnai, 12/11/15 http://goofynomics.blogspot.com)
Il dibattito economico, così come principalmente ripreso dai media, sembra oggi articolarsi tra due “fazioni” (apparentemente) contrapposte ma (certamente) complementari nella gestione del consenso e dell’opposizione al progetto ultra-liberista dell’euro, in quanto entrambe focalizzate sull’imprescindibilità “dogmatica” di quest’ultimo e sul ruolo del debito pubblico come causa, e non sintomo, della crisi. Da un lato quelli che Krugman, già nel 2013, definì gli austeriani, ossia gli economisti, per lo più esponenti delle oligarchie finanziarie, convinti che dalla crisi si possa uscire solo praticando politiche di austerità, e quindi, paradossalmente, impoverendo il Paese. Dall’altro i cosiddetti appellisti, ossia quella frangia di “esperti”, per lo più “de sinistra”, convinti che l’unica soluzione alla crisi sia la pubblicazione di accorati appelli e l’indizione di consultazioni popolari contro le politiche di austerità, perché un altro euro è possibile…
Entrambi gli schieramenti sembrano scientemente ad ignorare l’ormai celebre discorso tenuto alla Banca Nazionale Greca il 23 maggio del 2013 dal vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vitor Constâncio, nel quale si indicava ufficialmente la spirale dell’indebitamento privato che ha condotto ai salvataggi bancari, e non il debito pubblico in sé, come reale la causa dell’attuale crisi economica. Per motivi che, plausibilmente, spaziano dal mero interesse lobbistico alla professione ideologica, troppi “dotti” sembrano proprio non voler comprendere quanto sottolineato già nel 1957 da un noto premio Nobel come J. Meade dalle autorevoli pagine dell’Economic Journal (tra l’altro ripreso estesamente da un altro Nobel come R. Mundell), ossia che, venuta meno la flessibilità del cambio, l’eccesso di importazioni ed il conseguente squilibrio dei conti esteri possono essere corretti sono decurtando i redditi e, sostanzialmente, portando l’intero sistema all’implosione tramite la distruzione della domanda aggregata. Parimenti, sempre in presenza di un regime di assoluta rigidità del tasso di conversione della valuta, allentare i “cordoni” della spesa e rilanciare gli investimenti pubblici espansivi nei Paesi “periferici” della zona-Euro, paradossalmente, produrrebbe una crescita unilaterale del reddito e della domanda e, di conseguenza, pregiudicherebbe ulteriormente l’equilibrio delle bilance dei pagamenti e la tenuta dei conti pubblici di questi ultimi, implicando l’immediato ritorno a misure draconiane di risanamento. L’amara verità è che delle concrete politiche coordinate di investimenti pubblici rivolti alla crescita sono, nei fatti, politicamente e tecnicamente irrealizzabili nell’Eurozona e che, vigente l’euro, l’austerità (a questo punto, AUSTeurITA’!) è DAVVERO l’unica prospettiva. Come rilevato persino dall’austeriano Alesina già nel 1997, viene così meno anche il principale vantaggio sotteso all’unione economica, ossia la possibilità di sostenere reciprocamente la crescita dei Paesi membri attraverso la domanda aggregata di un unico grande mercato comune europeo. Non esiste politica dell’offerta che tenga, all’interno di quella colossale macchina per l’implosione della domanda che è l’Unione economica e monetaria europea
A questo punto è fondamentale ricordare che fin dall’inizio della crisi un ristretto gruppo di economisti ha posto in evidenza come la favola dell’austerità non rispecchiasse la realtà fattuale: nella maggior parte dei paesi in crisi il debito pubblico era stabile o decrescente. In ogni e ciascun caso era il debito privato con l’estero ad essere cresciuto, ovvero il debito delle imprese e delle famiglie residenti verso creditori (ovviamente privati) non residenti. Quindi ciò cui assistevamo non era una crisi di debito “sovrano”, ma di bilancia dei pagamenti con l’estero (che amara ironia – o che scaltra manipolazione! Chiamiamo “sovrano” il debito di stati che sono sempre più spossessati della propria sovranità economica dall’applicazione selettiva delle regole europee…). La crisi quindi non era stata causata dalla prodigalità dei governi, quanto dal fatto che l’euro, troppo debole per i paesi del Nord e troppo forte per quelli del Sud, aveva favorito l’accumularsi di enormi squilibri commerciali: le esportazioni dei paesi del Nord erano state favorite da una valuta relativamente debole, così come le importazioni dei paesi del Sud lo erano state dalla stessa valuta, che per loro era, però, relativamente forte. In più, l’euro aveva favorito l’incauto finanziamento di questi squilibri. In effetti, era proprio per questo che l’euro era stato fatto: per favorire l’integrazione finanziaria, cioè la capacità dei residenti di un Paese di indebitarsi coi creditori di un altro paese. (A. Bagnai, 12/11/15 http://goofynomics.blogspot.com)
In Italia, dal 2010 al 2014, il saldo della bilancia dei pagamenti (partite correnti) è migliorato di 5 punti rispetto al PIL. Un risultato che si è pagato a caro prezzo: il debito pubblico è aumentato di 17 punti di PIL, mentre la contrazione di quest’ultimo ha raggiunto il -2,6%.
Recita il mantra degli appellisti: il problema non è l’euro ma l’austerità. Che equivale a dire: il problema non è l’euro, ma è l’euro! E’ lo stesso Fondo monetario internazionale ormai a riconoscerlo espressamente, non senza autocritica. D’altronde, già un certo J.M. Keynes individuava nella flessibilità del cambio come strumento di riequilibrio della bilancia dei pagamenti la vera soluzione per evitare il disastro della deflazione. Qualsiasi libro di testo universitario non potrà quindi che indicare nella flessibilità del tasso di cambio valutario, ossia nella FINE DELL’EURO, la soluzione di crisi come quella che da troppo tempo stiamo vivendo. SOLO IL FINANZIAMENTO “MONETARIO” DELL’ECONOMIA DA PARTE DELLO STATO può essere risolutivo.
Certo, è abbastanza scontato che le grandi aziende sostengano instancabilmente il progetto della moneta unica, considerando la semplicità con cui l’euro permette loro di delocalizzare, speculare in prodotti finanziari e spostare indisturbate capitali. Al contrario, una riflessione in più si impone per i sindacati, di fatto ormai schierati contro i diritti dei lavoratori in favore delle grandi aziende, visto l’ormai inflessibile sostegno che unanimemente esprimono verso l’euro e “macelleria sociale” che esso comporta. Il tutto, forse, in nome di una lettura fuorviata e fuorviante dell’Internazionale comunista (espressione che, di per sé, implica l’esistenza di più Nazioni) ma, sicuramente, per uno smodato amore per il “macroscopico” che li rende, di fatto, conniventi con gli interessi delle multinazionali e nemici di P.Iva, artigiani e PMI.
L’insostenibilità di una moneta unica europea era, quindi, già da tempo un dato accertato dalla scienza economica e ben noto agli stessi politici fautori del progetto di unione monetaria, come oggi riconosciuto persino da L. Zingales, uno degli araldi dell’ortodossia economica italiana. Sono stati, del resto, gli stessi Prodi, Monti, Padoa Schioppa, Attali, Juncker, nelle loro dichiarazioni pubbliche, a riconoscere che l’euro sarebbe servito a governare i popoli europei a colpi di crisi, eludendo i normali processi democratici e ponendo ad ulteriore riparo da questi ultimi le insindacabili decisioni assunte dalle élites tecnocratiche auto-costituitesi alla guida del continente.
L’attuale Presidente della Commissione Europea, Junker, in un intervista al giornale tedesco “Spiegel” nel 1999 dichiarò: (Nelle sedi europee) decidiamo qualcosa, la rendiamo pubblica e aspettiamo un po’ per vedere cosa succede. Qualora non ci siano grosse proteste o opposizioni, dato che i più non capiscono assolutamente cosa abbiamo deciso, allora tiriamo dritto, passo dopo passo, fino al punto di non ritorno…
E’ opportuno ricordare, inoltre, che ogni euro “tagliato” alla spesa pubblica produce una decrescita più che proporzionale del PIL di circa un euro e mezzo, innestando circolo deflattivi viziosi. Ne consegue che, in presenza di una crisi sistemica come quella attuale, in nessun caso politiche procicliche di austerità possono migliorare il rapporto debito/PIL, ma al contrario solo peggiorarlo. E se è ormai appurato come, in Germania, i padroni del capitale amino l’euro perché impedisce la svalutazione dei loro crediti miliardari (e quindi del debito dei Paesi del Sud), le aziende esportatrici sono ormai in grossa difficoltà, perché il loro principale mercato di sbocco (ossia l’Europa, non certo la Cina) e sempre meno in grado di assorbire l’offerta dei loro prodotti visto il cittadino-medio dei Paesi dell’Unione continua inesorabilmente ad impoverirsi. Anche in Germania, quindi, i “mal di pancia” cominciano a non mancare e a tradursi sempre più in un sentimento anti-europeista, come testimoniato dalla costante ascesa del movimento di estrema destra Alternative für Deutschland.
LA CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE
Attraverso uno studio condotto dall’economista internazionale Atish R. Ghosh, lo stesso Fondo Monetario Internazionale riconosce oramai che la flessibilità del cambio è essenziale per assicurare un corretto aggiustamento degli squilibri esterni tra Paesi, ossia quelli della bilancia dei pagamenti. Ripristinare la libera fluttuazione dei tassi di conversione delle valute è, infatti, l’unico strumento realmente efficace per prevenire o risolvere le crisi connesse al debito estero.
Un simile “ravvedimento” oggi non è estraneo neppure agli esponenti più avveduti di quella sinistra, probabilmente, ancora “proletaria”, rappresentata da esponenti come l’ex-ministro Stefano Fassina, il quale ha apertamente ammesso che se non svaluti la moneta, devi svalutare il lavoro. In verità, i Paesi come la Germania che, in questo momento storico, registrano un forte surplus nella bilancia commerciale con l’estero grazie alla scelta politica di adottare una moneta che non riflette equamente il valore relativo della propria economia, tollerano e legittimano al proprio interno l’inasprimento della sanguinosa guerra tra classe lavoratrice e padroni del capitale, per di più favorendo gli interessi dei privilegiati ed imponendo beffardamente anche agli Paesi l’adozione di simili modelli di scontro sociale, in una sfida ormai paneuropea a chi si rende più competitivo sulla pelle dei più deboli.
Naturalmente, l’uscita dall’euro non è di per sé sufficiente. La reintroduzione della facoltà di “battere moneta” da parte dei singoli Stati è solo uno strumento volto al ripristino di quella sovranità politico-democratica troppo a lungo svilita dalle élites tecnocratiche sponsorizzate dalla finanza apolide e globalista. La rediviva sovranità dello Stato, e del Popolo che esso esprime, deve infatti tornare ad essere esercitata nelle sedi istituzionali appropriate, che a loro volta devono ricondotte nell’alveo della sana rappresentanza democratica e delle regole del processo elettorale.
Solo così la globalizzazione potrà tornare ad essere un’opportunità per un Paese da sempre ricco di conoscenze, competenze ed intraprendenza come il nostro, ripartendo, inoltre, da alcune fondamentali ed ineludibili priorità, individuate attraverso lo studio dei dati economici degli anni successivi alla Grande Depressione e del periodo di boom economico del secondo dopo-guerra:
a) stabilire un nuovo patto tra le parti sociali che permetta all’economia di stabilizzarsi e crescere in maniera equa e sostenibile, senza demolire il mercato interno, incentrato sul ripristino di meccanismi di tutela ed indicizzazione del salario dei lavoratori;
b) ripristinare meccanismi di regolazione dei mercati finanziari che invertano il trend di selvaggia deregulation dal quale ha tratto origine il baratro dell’attuale crisi. Tali misure devono consentire, da una parte, la tutela del risparmio e l’esercizio del credito e, dall’altra, permettere, a chi vuole consapevolmente correre rischi, di trarne gli eventuali profitti ma anche obbligare gli speculatori a sostenere i relativi costi e le possibili perdite derivanti dalle speculazioni, senza riversarli sulla collettività. E’ necessario, quindi, reintrodurre:
– la fondamentale separazione tra banche commerciali ed istituti finanziari di investimento (cd. banche d’affari);
– un pervasivo ed efficace controllo antimonopolistico nel settore bancario;
– il reintegro delle funzioni della Banca d’Italia nel perimetro del potere esecutivo di Governo.
Nel quadro degli accordi di Bretton Woods, J.M. Keynes propose un sistema per disincentivare l’accumulazione di credito verso l’estero da parte dei Paesi in surplus commerciale e la conseguente “tesaurizzazione” valutaria, con l’introduzione del pagamento di un interesse anche sulle posizioni creditorie degli Stati: il BANCOR. In realtà, una funzione analoga e molto meno burocratizzata può essere intrinsecamente svolta dal ripristino della libera fluttuazione dei cambi.
Effettivamente, sarebbe auspicabile una nuova conferenza internazionale sui temi valutari che determinasse la introduzione di una riserva valutaria comune utile a fronteggiare le possibili crisi di liquidità degli Stati ed istituisse una vera e propria Banca del mondo, preposta alla gestione dei saldi creditori e debitori scaturenti dai flussi internazionali del commercio, con l’emissione di un’unità di conto internazionale (un nuovo Bancor) strutturata in modo da scoraggiare la sua accumulazione, tramite l’obbligo di corrispondere un interesse anche sui saldi attivi.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, appare evidente che un valido argine alla disastrosa corsa alla competitività al ribasso in atto tra i Paesi dell’Unione sarebbe inoltre rappresentato dall’armonizzazione legislativa e regolamentare, a livello europeo, in materia di diritto del lavoro, delle forme contrattuali, dei sistemi previdenziali, dei meccanismi e dei regimi retributivi nonché delle prerogative sindacali.
Le élites tedesche sembrano aver ancora interesse ad ignorare le criticità del cambio fisso nonostante le dinamiche relative al mercato dei capitali, innestate da una moneta sottovalutata come l’euro, stiano già pesantemente condizionando gli investimenti produttivi anche in Germania, penalizzando infrastrutture, ricerca e sviluppo non più spinte dal vincolo esterno. In realtà, consentendo artificialmente al cambio “reale” della valuta tedesca di rimanere rigidamente sottovalutato, la moneta unica avvantaggia la Germania solo nel breve periodo. Infatti, a lungo andare tutto ciò distrugge proprio i principali mercati di sbocco per i prodotti tedeschi, condannando la stessa Germania ad una crescita asfittica che può persino a sua volta minare la sostenibilità del suo sistema pensionistico. Impossibile negare le gravi implicazioni anche sul lato dell’offerta dove la Germania, non avendo al momento convenienza a rilanciare le sua dotazioni infrastrutturali, sta seriamente compromettendo la propria crescita di lungo periodo, ulteriormente gravata dagli spettri della disuguaglianza sociale e dell’invecchiamento demografico.
Affermare che la Germania sia la locomotiva d’Europa è, quindi, ancora una volta completamente infondato perché il suo totalitarismo “mercantilista”, dell’Europa, è ormai solo il principale problema. La Germania è l’unica ad arricchirsi a spese degli altri Paesi dell’Unione, con un saldo delle esportazioni superiore al 7% rispetto al PIL già negli otto anni precedenti al 2014. Tutto ciò mentre già dal 2011 le regole europee impongono che i Paesi esportatori che producono un saldo delle partite correnti “eccessivamente” positivo, quindi con un eccesso di surplus estero quantificato, tra l’altro abbastanza simbolicamente, nel 6% del PIL nella media dei tre anni, debba essere sottoposta all’attenzione della Commissione Europea nell’ambito di una specifica procedura per la prevenzione gli squilibri macroeconomici.
Di locomotiva, quindi, nell’attuale Germania c’è ben poco. Perché per aggiustare i conti i Paesi dell’Eurozona che sono in deficit (anziché essere trainati) hanno dovuto recuperare competitività di prezzo e ridimensionare gli standard di vita, generando deflazione e riduzione della domanda che non sono state compensate, come sarebbe stato logico e opportuno, da politiche espansive nei Paesi in surplus, Germania anzitutto. L’atteggiamento della Germania, analizzandolo nella profondità del dato delle partite correnti, è l’esatto opposto di quello degli Stati Uniti che da anni generano un saldo delle partite correnti negativo rispetto al PIL e quindi assurgono per certi versi al ruolo di locomotiva dell’economia globale, immettendo ricchezza netta e permettendo a molti Paesi di esportare. (V. Lops, il Sole 24 ore, 19/01/14 da http://www.ilsole24ore.com)
In questo contesto, il fatto che gli Stati Uniti, a loro volta, non siano oggi più disponibili a ricoprire il ruolo di compratori di ultima istanza del commercio mondiale, rappresenta un’ulteriore complicazione in un quadro già seriamente compromesso. Le pressioni USA per l’instaurazione dell’area di libero scambio transatlantica del TTIP (e successivamente, in tempi recenti, per l’imposizione di dazi e tariffe specialmente, e certo non a caso, sui prodotti tedeschi) scaturiscono proprio dall’aggravarsi degli squilibri della loro bilancia commerciale e dal progressivo abbandono del dollaro come valuta di riferimento da parte delle economie emergenti, con gli effetti depressivi che queste condizioni potrebbero produrre sull’economia americana.
FACCIAMO I COMPITI A CASA (prima parte)
Ritengo che effettivamente ci siano poteri economici dominanti che dopo la scomparsa del comunismo – che era la loro paura – hanno ripreso i vecchi vizi: sono antidemocratici, pongono l’accumulazione capitalistica al vertice della scala dei valori sociali e […] ci riescono sfruttando l’ignoranza del popolo su materie difficili e delicate, lo terrorizzano. Stiamo attraversando la fase del terrore. (P. Savona, introduzione a La fine del sogno europeo di F. Heisbourg, luglio 2014)
Non è possibile, inoltre, non soffermarsi sulle “confessioni” anti-democratiche di Mario Monti quando, in più occasioni, ha affermato come occorra porre le scelte economiche, e le stesse istituzioni europee, al riparo dal processo elettorale. La minaccia esterna di oggi si chiama concorrenza. Questo è un fattore potente di spinta per l’integrazione, così come l’immigrazione. Le paure sono state all’origine dell’integrazione (europea). Le paure hanno cambiato natura, però rimangono tra i motori dell’integrazione. […] E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni (di sovranità) solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto, visibile, conclamata. […] Abbiamo bisogno delle crisi per fare passi avanti. (M. Monti, libro/intervista sull’Italia in Europa, 1998)
Affermazioni inquietanti che, sublimando nel motto non ci sono alternative, incarnano quella dittatura delle élites cosmopolite profetizzata dal A. Huxley nel suo Ritorno al mondo nuovo (1958).
Non è insolito imbattersi in elogi di Adam Smith come teorico del liberismo, per quanto altrettanto spesso si ometta faziosamente l’importanza che il filosofo ed economista scozzese era solito attribuire alle politiche protezionistiche per il controllo delle importazioni di quei beni stranieri che avrebbero potuto nuocere alla produzione di omologhi nazionali.
Intanto, da decenni si intensifica in tutto il mondo la polarizzazione di uno scontro tra l’”alto” ed il “basso” della società; tra l’uomo “Grosso” e l’uomo “Piccolo”; tra i padroni assoluti del denaro e una moltitudine proletaria “allargata” fino a comprendere i liberi professionisti, gli artigiani ed i piccoli e medi imprenditori; tra l’oligopolio tecnocratico che detta l’agenda delle “riforme” e la pseudo-democrazia in uno Stato che, ormai, sembra debba solo fare i compiti a casa; tra il potere “senza confini” ed il popolo lusingato dal “debito facile” e sottomesso attraverso la disinformazione ed il “senso di colpa” auto-razzista.
E tutto ciò, di certo, non avviene “semplicisticamente” a causa della rivoluzzzione diggitale, visto che il progresso tecnologico, a qualsiasi livello, è sempre stato una costante storica della dimensione umana, fin dai tempi della pietra focaia e della ruota. In un’economia equamente strutturata, il progresso tecnologico produce un aumento della produttività da cui scaturiscono specializzazione e, quindi, apprezzamento del lavoro umano. Non la schiavitù. Sono lo scollamento tra la crescita della produttività ed il livello reale dei salari, insieme al “ricatto” della precarietà e delle delocalizzazioni, a svilire, de-qualificare e deprezzare il lavoro e ad intaccare, a loro volta, drasticamente la produttività dei lavoratori.
Che la distinzione destra/sinistra sia ormai superata è tesi da respingere perché è stata una della condizioni culturali del trionfo del neoliberismo (e della tecnocrazia). (M. Porcaro, agosto 2014 https://sinistranoeuro.wordpress.com/2014/08)
L’esperienza storica, quindi, ci mostra che i due problemi coi quali ci confrontiamo, quello di una crescente disuguaglianza e quello di un’accumulazione insostenibile di debiti, sono connessi da precise relazioni causali, e che una loro soluzione ordinata richiede una diversa gestione dei mercati finanziari e una diversa conduzione della politica monetaria. Partendo dall’analisi del “sintomo” del debito, in caso di suoi grandi accumuli le soluzioni possibili sono tre:
a) non ripagarlo (default o ristrutturazione). Il ripudio del debito, comunque, deve essere in qualche modo accettato dalle controparti…ma poi dalla Merkel ci vai tu? E gli investimenti futuri?;
b) ripagarlo in moneta drasticamente svalutata. L’iperinflazione è, essenzialmente, un default Un’eventualità oggi tecnicamente impossibile in Italia, visto il corrente contesto deflazionistico che, plausibilmente, resisterebbe anche all’uscita dalla moneta unica. L’uscita dall’euro implicherebbe un aumento del prezzo delle valute estere nell’ordine del 20-30% (a seconda di quanto sarà «basso» l’euro al momento dell’uscita), con riflessi sul prezzo della benzina attorno al 6%, cioè inferiori ai 15 centesimi al litro (Bagnai e Mongeau Ospina, 2014), e con un impatto sull’inflazione molto inferiore, pari a 1 o 2 punti percentuali in più, secondo uno studio della BCE citato da Livini (2014), cioè a quello che ci manca per arrivare al 2% di inflazione annuale considerato ottimale dalla Banca Centrale Europea;
c) intraprendere un percorso di crescita sostenuta del PIL nominale, cioè del volume dei beni e servizi immessi sul mercato, e del loro prezzo, tollerando, inoltre, una moderata inflazione. E’ sufficiente leggere, per esempio, il manuale Elementi di politica economica, di N. Acocella (2009): in tal caso [il finanziamento con moneta] la politica fiscale espansiva esplica appieno i suoi effetti e si giustifica il ruolo preminente attribuitole da Keynes. Da questo punto di vista, uno stretto coordinamento della politica fiscale e di quella monetaria si rivela prezioso per ottenere incrementi di reddito e di occupazione; al contrario, può nuocere l’indipendenza della Banca centrale […]. Il finanziamento monetario può provocare, d’altro canto, aumenti di prezzi in presenza di pieno impiego o di strozzature settoriali.
Al contrario, il trattato di Maastricht vieta la concessione di prestiti, ossia il finanziamento “monetario”, da parte delle banche centrali dei singoli Stati alle istituzioni pubbliche o alle imprese controllate dallo Stato. Una regola “suicida” per l’economia, specialmente se coordinata all’obbligo del pareggio di bilancio ed al vincolo del 3% nel rapporto tra indebitamento e PIL (che per di più sembra valere solo per gli “inaffidabili” Paesi del sud Europa). Lo afferma in modo limpido Leijonhufvud (2008): Quando la politica monetaria comporta la scelta di inflazionare o deflazionare l’economia, di favorire i debitori o i creditori, di salvare in modo selettivo alcune banche e non altre, di permettere o impedire alle banche comportamenti collusivi, nessun Paese democratico può lasciare decisioni simili a tecnici non eletti. La dottrina dell’indipendenza [ossia del “divorzio fra” Tesoro e Banca d’Italia] diventa impossibile da sostenere. In altre parole: chi oggi difende l’euro, è contro la democrazia!
Le riforme strutturali delle quali abbiamo davvero bisogno richiedono che vengano smontate pezzo per pezzo le istituzioni fallimentari che hanno messo in crisi la nostra economia, e soprattutto la nostra democrazia, seguendo quattro linee guida:
- uscire dall’euro, come affermazione di sovranità e di democrazia, riprendendo il controllo della politica valutaria;
- ristabilire il principio che la Banca Centrale è uno strumento del potere esecutivo, e non un potere indipendente o etero-diretto all’interno dello Stato;
- riprendere il pieno controllo della politica fiscale, non più costretta ad agire in funzione prociclica (cioè a rispondere alle crisi con misure depressive);
- adottare una politica “equilibrata” di scambi commerciali con l’estero, basata sul principio che squilibri persistenti della bilancia dei pagamenti, siano in surplus o in deficit, devono essere simmetricamente combattuti, promuovendo questo assetto nei confronti dei partner commerciali nell’ambito delle opportune sedi istituzionali (il WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, continuerebbe infatti ad esistere anche in caso di scioglimento dell’euro e persino della stessa Unione Europea);
- intervenire sulla politica dei redditi ripristinando meccanismi di adeguamento (indicizzazione, scala mobile) che proteggano il salario reale e l’effettivo potere d’acquisto, aggredendo alla radice gli squilibri nella distribuzione del reddito all’origine della crisi debitoria e di quella di domanda.
E’ ormai chiaro che tutto quanto sopra descritto possa essere realizzato solo a livello nazionale, considerata l’assenza di una generale volontà politica condivisa tra gli Stati membri e, comunque, la mancanza di organi europei adeguati e legittimati democraticamente ad adottare simili soluzioni. Senza contare le ormai profonde differenze strutturali rimarcate dalla crisi tra le economie dei diversi Paesi europei che, di conseguenza, al giorno d’oggi non posso che esprimere esigenze macroeconomiche profondamente divergenti.
Una volta liberata dagli insensati vincoli europei che costringono il Governo centrale a tagliare gli investimenti e a comprimere i trasferimenti agli enti locali, la politica fiscale dovrebbe, nel breve periodo, stimolare l’economia attraverso una politica di “piccole” opere volte a rilanciare l’occupazione, riportando il tasso di disoccupazione dall’attuale 13% (ma in realtà molto al di sopra delle stime ufficiali!) sotto il 10%, riattivando così il tessuto economico del Paese attraverso la rivalorizzazione delle piccole e medie imprese, tramite:
- la riqualificazione del patrimonio pubblico (edilizia scolastica, patrimonio artistico e archeologico, etc.);
- la messa in sicurezza del territorio (viabilità, monitoraggio e gestione del rischio idrogeologico, ristrutturazione antisismica, etc.);
- l’integrazione e riqualificazione degli organici della pubblica amministrazione, stabilizzando le posizioni precarie, normalizzando i percorsi di carriera e le procedure di reclutamento.
Nel medio-lungo periodo, la politica fiscale dovrebbe finanziare e gestire misure che favoriscano la crescita sostenibile e la competitività del Paese, focalizzandosi sugli assi prioritari:
- definire le linee di un piano energetico nazionale che affronti il tema del contenimento degli sprechi e dell’incentivazione delle energie rinnovabili, con l’obiettivo strategico di ridurre la dipendenza da fonti combustibili fossili già definito anche dalla strategia europea 20-20-20;
- adeguare, anche in quest’ottica, gli investimenti in istruzione e ricerca al livello dei partner europei, portando la spesa in ricerca e sviluppo dall’1% al 2% del PIL, riaffermando così il ruolo chiave dello Stato nell’incentivazione e nella tutela della ricerca fondamentale;
- recuperare il digital divide, il ritardo nell’uso delle tecnologie digitali che separa l’Italia dagli altri Paesi industrializzati e ne penalizza la crescita, allineandoci ai requisiti già evidenziati dall’Agenda digitale europea;
- adeguare la dotazione infrastrutturale del Paese, con particolare riguardo alle reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, non avendo (purtroppo e finalmente) più rilevanza strategica per l’Italia supportare le vendite su gomma dell’ormai ”americana” FIAT, oggi FCA.
- promuovere una riforma strutturale della pubblica amministrazione volta all’abbattimento dei “veri” costi della politica e della corruzione, incidendo soprattutto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica (in particolare sulla disciplina delle nomine e sul ripristino dei controlli di legittimità sugli atti) e su quella delle autonomie locali attuata con la riforma “de sinistra” del Titolo V della Costituzione (Barra Caracciolo, 2011).
Sono questi gli unici “compiti a casa” che dobbiamo fare, con l’obiettivo di rianimare la nostra economia utilizzando, sotto il controllo delle istituzioni democratiche, le leve di manovra monetaria e fiscale che ogni Stato sovrano nel mondo ha a disposizione, tranne i 18 “infelici” dell’Eurozona.
FACCIAMO I COMPITI A CASA (seconda parte)
Uno degli scopi di quest’analisi è analizzare la political economy della nostra crisi. La traduzione italiana di questo termine tecnico non è economia politica. Per political economy si intende, nella letteratura economica, lo studio interdisciplinare di come le istituzioni politiche e il sistema economico interagiscano nel determinare le dinamiche economico-sociali. Insomma: l’economia politica in senso stretto spiega come si comporta un imprenditore per massimizzare il proprio profitto, o un consumatore per massimizzare la propria soddisfazione, o un governo per massimizzare l’occupazione. La political economy va alla ricerca delle motivazioni economiche di certe scelte istituzionali, e di converso studia come certe scelte politiche condizionino gli agenti economici.
La nostra non nasce come crisi di debito pubblico, ma di debito estero. Da anni l’Italia è debitrice netta verso l’estero, quindi spende per importazioni più di quello che incassa per esportazioni. Di conseguenza, il Paese è costretto a indebitarsi col resto del mondo per poter continuare ad acquisire le risorse di cui ha bisogno. Quando i creditori esteri sono andati in crisi (in pratica, quando la Germania, che aveva investito “stupidamente” nel mercato subprime, si è trovata nell’esigenza di passare all’incasso dei suoi crediti verso altri Paesi: Grecia, Spagna, etc.) è iniziato il disastro nel quale ci troviamo.
Dal 1980 a oggi l’Italia ha conosciuto un’unica situazione nella quale, pur avendo un debito netto, si è trovata in situazione di surplus, di accreditamento netto, e quindi ha potuto rimborsare i propri debiti esteri, riducendoli. È successo tra il 1993 e il 1999, quando il saldo delle partite correnti passò rapidamente in positivo, nella parentesi tra due episodi di deterioramento strutturale sempre legati all’adozione di un cambio fisso, ossia l’entrata nello SME (1986-1992) e la rivalutazione della Lira rispetto all’ECU (dal 1999) poi sfociata nella parità rigida con l’euro.
Nel 1992 l’Italia riallineò il cambio all’interno dello SME, le esportazioni decollarono, le importazioni diminuirono, per poi riprendere. Furono usati due strumenti: la politica valutaria, in senso espansivo, e quella fiscale, in senso restrittivo. Le cose andarono esattamente all’opposto di oggi: i conti esteri furono rimessi in ordine facendo crescere le esportazioni più delle importazioni. Più precisamente: la differenza fra il 1992 e il 2011 è che nel 2011 sono state adottate solo manovre “lacrime e sangue”, volte alla distruzione della domanda interna tramite la leva fiscale in chiave di contenimento dell’indebitamento verso l’estero, senza però l’effetto espansivo del riallineamento del cambio.
Proseguendo nell’analisi dei fondamentali macroeconomici, le principali differenze fra la situazione attuale e quella sperimentata nel 1992 sono:
– l’attuale contesto europeo è caratterizzato da una crescita asfittica e da un livello ridotto della domanda a causa dell’austerità competitiva imposta dall’euro (quindi l’export “tirerebbe” meno);
– i sei anni di crisi hanno accelerato la nostra deindustrializzazione, e questo potrebbe ostacolare l’adeguamento della produzione all’incremento della domanda, con possibili problemi di filiera produttiva e conseguenze inflazionistiche;
– d’altra parte, a differenza del 1992, oggi i nostri conti esteri sono in ordine, perché abbiamo già effettuato la parte «dolorosa» della manovra: l’uso della politica di bilancio dell’austerità per diminuire le importazioni. Oggi l’Italia parte da una posizione di surplus estero pari all’1% del PIL, contro il deficit estero al 3% registrato nel 1992;
– grazie all’implosione della domanda mondiale, oggi i prezzi di molte materie prime, fra le quali il petrolio, sono declinanti per eccesso di offerta, nonostante i lodevoli tentativi degli Stati Uniti di “far casino” in giro per il mondo allo scopo di tenerlo alto, rendendo conveniente il loro costoso shale gas.
E’ possibile quindi procedere con l’analisi di quale sarebbe il potenziale impatto sull’economia italiana di un riallineamento una tantum del tasso di cambio, ovviamente nell’ipotesi di uscita dell’Italia dall’euro (o, di uscita dell’euro dall’Italia, ad esempio per abbandono della Germania!)
Gli scenari prefigurabili sono tre:
- svalutazione del cambio della Nuova Lira del 20% rispetto a tutti i partner commerciali: scenario puramente teorico;
- svalutazione del cambio della Nuova Lira del 20% rispetto al nucleo dell’Eurozona e del 10% rispetto ai paesi extraeuropei, con rivalutazione del 10% rispetto alla periferia dell’Eurozona: se l’Italia uscisse dall’Eurozona, l’Eurozona di fatto si dissolverebbe. Il risultato sarebbe che i Paesi del Nord rivaluterebbero rispetto a noi (noi svaluteremmo rispetto a loro), ma quelli del Sud, che stanno peggio in termini di debito estero, svaluterebbero rispetto a noi (noi rivaluteremmo rispetto a loro). Dato che oggi l’euro sta già scendendo, l’entità della nostra svalutazione rispetto al dollaro sarebbe verosimilmente inferiore a quella della nostra svalutazione rispetto al centro dell’Eurozona;
- come al punto 2, ma con politiche fiscali espansive mirate sull’obiettivo del pareggio della bilancia del pagamenti (es: un “ricambio generazionale” anche nel pubblico impiego): essendo i conti esteri italiani già in ordine, la svalutazione aprirebbe «spazio fiscale», ossia permetterebbe di adottare politiche espansive senza creare problemi sul fronte della bilancia dei pagamenti e nemmeno sul fronte del debito pubblico (perché l’impatto della maggiore spesa sul debito pubblico sarebbe compensato da quello della maggiore crescita nominale, ovvero crescita del prodotto e dei prezzi).
Quando si considera di un riallineamento del 20%, si fa, in ogni caso, rifermento a quello che accadrebbe in media nell’arco di un anno: non è possibile escludere quello che tecnicamente si chiama un overshooting, ovvero un «superamento del bersaglio», con riallineamenti magari per qualche settimana superiori al 30%. Al fine di fugare timori tanto infondati quanto spesso strumentalizzati da una certa politica del “panico”, è necessario considerare che:
– una valuta italiana troppo “debole” non converrebbe comunque ai nostri competitors: pensare che «gli speculatori» metterebbero la Lira in ginocchio significa ignorare che in questo modo i prodotti italiani beneficerebbero di un enorme vantaggio competitivo sui mercati internazionali: le banche centrali dei Paesi nostri concorrenti interverrebbero per evitarlo;
– la svalutazione delle nostra valuta verso l’estero e la perdita del potere di acquisto interno sono due fenomeni separati, operanti secondo dinamiche differenti. La perdita di valore “esterno” di una moneta non coincide con la caduta del suo valore “interno”, cioè del suo potere di acquisto, che è infatti intaccato molto più dalla precarietà e dalla “svalutazione” del lavoro, insieme alla de-indicizzazione dei salari, e molto meno dal mutamento dei prezzi delle materie prime (che, tra l’altro, avviene in continuazione);
– la svalutazione valutaria e l’inflazione interna, parimenti, non seguono dinamiche speculari. E’ stimato che una svalutazione della moneta del 20% determinerebbe ad un’inflazione cumulata di circa il 5% in 5 anni (più che compensata dai benefici distribuiti della crescita economica). La stessa Confindustria ha dichiarato che anche una svalutazione del 10% dell’euro comporterebbe solo un’inflazione di un punto percentuale, con un guadagno del 9% in competitività sul prezzo.
Gli effetti diretti sul benessere dell’Italia e di tutti Italiani (non solo dei soliti “noti”, non a caso convinti “euristi”) sarebbero quindi immediati ed in totale controtendenza rispetto alle desolanti stime del “meno” o del “più zero-virgola” a cui siamo ormai tristemente abituati.
Tutta l’evidenza disponibile suggerisce che una svalutazione inattesa può essere piuttosto efficace [nel ridurre la disoccupazione e aumentare il reddito], anche nel contesto europeo. I vantaggi conferiti dalla flessibilità del cambio sono tanto più utili quanto più la rigidità del mercato del lavoro rende costoso adattarsi altrimenti agli shock esterni. Questa conclusione è rinforzata dall’osservazione che prezzi e salari sono in qualche modo rigidi in termini nominali, e quindi una svalutazione può influenzare prodotto e disoccupazione anche se i salari reali sono piuttosto rigidi. (M. Obstfeld, 1997) Tutto questo è invece chiaramente impercorribile senza un ritorno alla Lira. Se l’Italia intraprendesse una manovra di carattere espansivo senza prima ampliare il proprio spazio fiscale tramite un riallineamento del cambio, l’unica conseguenza sarebbero un netto peggioramento del deficit della bilancia commerciale estera, con un aumento delle importazioni, e l’immediato ripristino di misure di austerità ancora più recessive. Se si tentasse, invece, una svalutazione dell’euro, si potrebbe sicuramente registrare un miglioramento dei saldi verso gli USA e il resto del mondo, sempre che gli altri Paesi non reagiscano a loro volta “sovranamente”, con una svalutazione o, addirittura, l’imposizione di misure tariffarie. Il prezzo di questa incerta ed effimera operazione sarebbe, inoltre, un sicuro peggioramento dei saldi commerciali verso l’Eurozona e i Paesi OPEC, il primo dovuto a un effetto reddito (il maggior reddito causato dalle esportazioni extra-Eurozona alimenterebbe importazioni dall’Eurozona), e il secondo anche da un effetto prezzo (il maggior costo del dollaro in euro farebbe peggiorare la bilancia energetica dell’Italia).
La nostra società sta andando a schiantarsi contro l’iceberg della disuguaglianza. La metafora del Titanic è stata introdotta con successo da V. Giacché nel 2012. In proposito, la proposta di “punire” i “ricchi” è, in qualche modo, speculare a quella di una corretta remunerazione dei “poveri”, ottenuta ridistribuendo il reddito secondo quanto la teoria economica prescrive e la storia ci dice possibile. Ciò che rende “sospetta” questa proposta, apparentemente più risolutiva, è proprio il fatto che provenga dai fautori di quella stessa fabbrica di disuguaglianza che è proprio l’euro. E’ importante sottolineare che, negli Stati Uniti, l’evoluzione della disuguaglianza e della concentrazione nella distribuzione dei redditi ha seguito uno schema cosiddetto a “U”, in quanto nel 1913 l’1% della popolazione deteneva il 20% del reddito nazionale, che precipitò nel dopoguerra per oggi ripristinare una situazione analoga al 1913. In Europa, al contrario, l’andamento segue uno schema a “L”, ossia la condizione di partenza era simile a quella americana, ma successivamente al dopoguerra il reddito percepito dall’1% della popolazione si è stabilizzato intorno al 10% .
Bene, chi propone l’”aggressione” all’1% dei ricchissimi, evidentemente non considera che questo 1% è composto da persone che hanno i mezzi economici, politici, lobbistici e mediatici per difendersi e rendere se stessi ed i propri capitali intoccabili ed irreperibili: lo hanno dimostrato proprio indirizzando il sistema politico ad imporre sui loro patrimoni delle aliquote sempre più favorevoli e trasferendo i propri asset nei paradisi fiscali. I novelli Robin Hood, quindi, non tengono certo in considerazione il fatto che i “rapinati” saranno i soliti “capri espiatori” della classe media, per lo più piccoli-medi imprenditori, stipendiati e pensionati a reddito fisso, nonché, come sempre, TUTTI I PROPRIETARI DI UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO e non certo il principe Giovanni e la sua corte. I conti poi non tornano, quando ci viene suggerito di continuare ad inquadrare questa “aggressione” ancora nell’ambito di quella che è stata la macchina europea della disuguaglianza (l’euro) ed evolvendo (si fa per dire) verso più Europa. E poi, il gettito delle imposte così raccolte in tutto il continente da chi sarebbe gestito e dove sarebbe destinato? E per decisioni di chi? Finirebbero in mano alle lobby dei potentati e ai partiti, con le loro schiere di cooptati compiacenti? O sarebbero democraticamente ripartite e gestite per sostenere i Paesi ed i cittadini che più ne hanno bisogno? Le intenzioni dichiarate sono sempre quelle, buoniste e politicamente corrette, ma poi, in concreto, questi investimenti “produttivi” dove si fanno? In Germania o in Italia? E chi dovrebbe decidere tra le due? Un tedesco magari….o, ancor peggio, un italiano che agisca non per l’interesse dell’Italia, ma nell’interesse dell’Europa (parafrasando un noto tweet di Matteo Renzi pubblicato attraverso l’account Twitter del Partito Democratico il 27/06/2016)
Un’unione politica che, evidentemente, nasce e vive come un’unione asimmetrica fra Paesi forti e Paesi deboli, serve solo a stritolare questi ultimi e, al loro interno, ad avvantaggiare le élites locali, a discapito della massa sottomessa dei cittadini. L’albero si conosce dai frutti. I frutti di questa Europa sono sotto gli occhi di tutti.
Chi vi dice che l’Italia non può farcela perché è troppo “piccola” o è uno dei soliti disfattisti anti-italiani o è un superficiale, con una visione pre-ottocentesca del mondo, di quelli che individuano il successo di uno Stato nella sua “grandezza” geografica e demografica, anziché nel benessere dei suoi cittadini. Mai come in economia le “dimensioni” non contano, come dimostrato da molti “piccoli” Stati indubbiamente ricchi e prosperi, ma anche dallo stesso numero in crescita degli Stati nazionali presenti nel mondo. Il problema è sempre e soltanto la produttività, frustrata da precarietà e svalutazione salariale. Analogamente, le statistiche dimostrano che l’export italiano, come l’economia di questo Paese nel suo insieme, resiste soprattutto grazie alle piccole e medie imprese, mentre le “grandi” imprese, così “amate” dai sindacati e da certa sinistra, continuano ad emigrare all’estero insieme ai loro lobbisti. Il modello produttivo italiano non solo ha sempre funzionato, ma ci ha assicurato crescita e benessere finché gli è stato permesso di farlo. Quindi l’Italia può farcela, e può farcela da sola, ossia sciolta da un vincolo monetario esterno suicida.
Grande è bello è solo uno dei tanti “frame” stereotipati ed auto-razzisti, promossi da chi ha problemi ideologici con il concetto di Stato e di Popolo italiano.
Non si tratta, però, di opporsi a priori al “progetto” europeo. Non si tratta, infatti, di mollare gli ormeggi e “vagare” per il Mediterraneo dove, fra l’altro, tutto saremmo tranne che soli, anche per effetto delle “lungimiranti” politiche di questa Europa che porta la “pace”, e che ha contribuito a trasformare la fascia costiera meridionale del Mare Nostrum in un focolaio di disperazione e morte, lasciando all’Italia, e solo all’Italia, l’incombenza di gestirne le inevitabili conseguenze migratorie e umanitarie: basti pensare alla vicenda libica, nella quale gli interessi del nostro Paese e, visti i risultati, delle stesse popolazioni coinvolte, sono stati fortemente compromessi da iniziative di altri Paesi, non particolarmente coordinate a livello europeo. Si tratta di riconoscere che l’”Europa” non funziona perché non può funzionare, perché le élites che l’hanno costruita hanno dichiarato guerra non solo alle classi subalterne, ma anche e soprattutto alla logica (economica e politica).
Come ampiamente dimostrato dal Premio Nobel J. Meade già nel 1957, finché persisteranno disparità strutturali rilevanti fra i Paesi europei, di tale entità per cui sia utopistico ovviare con dei trasferimenti [ed ammesso che vi sia la volontà politica condivisa di effettuarli], un percorso ordinato di integrazione economica e politica richiede che si mantenga la flessibilità dei cambi nazionali. Pertanto, la politica deve essere orientata al pareggio della bilancia dei pagamenti con l’estero, più che del bilancio pubblico. Quello che serve ai Paesi europei non è il fiscal compact, ma un EXTERNAL COMPACT. Il precursore della BCE, il FECOM (Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria) fu istituito nel 1973 proprio con questa finalità: coordinare l’uso delle riserve fra i Paesi aderenti e rifinanziare gli squilibri temporanei. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, del resto, già prevede che le politiche economiche dei Paesi membri siano coordinate. Questo interesse legittimo dovrebbe costituire la base su cui stabilire un effettivo, simmetrico e preventivo monitoraggio degli squilibri macroeconomici (ben diverso da quello inefficace, asimmetrico e postumo proposto nel 2011 dalla Commissione europea).
Un percorso di integrazione europea rinnovato e razionale, quindi, può essere ancora oggi articolato sui tre principi indicati da Meade (1957):
- i Paesi partecipanti devono impegnarsi a effettuare politiche di stabilizzazione macroeconomica interna, volte nei Paesi in surplus a evitare la deflazione (il contrario di quanto ha fatto la Germania) e nei paesi in deficit a evitare l’inflazione;
- gli aggiustamenti di cambio devono avvenire in regime di fluttuazione libera e rispettando un principio di simmetria, ovvero la valuta dei Paesi in surplus deve essere libera di apprezzarsi, quella dei Paesi in deficit deve essere libera di deprezzarsi;
- deve essere creato un meccanismo (un Fondo monetario europeo, per intendersi) che sia in grado di fornire valuta di riserva ai Paesi in deficit, consentendo loro di gestire senza traumi economici e sociali il processo di aggiustamento.
Tutto ciò nel contesto di un principio di coordinamento in base al quale ogni Paese membro riconosce formalmente che gli altri membri hanno un interesse legittimo alla stabilizzazione della sua economia, per quanto riguarda redditi, prezzi e costo del lavoro, e, in particolare, al fatto che Paesi in surplus evitino la deflazione e Paesi in deficit evitino l’inflazione.
Sarebbe sbagliato, dice J. Meade, pensare che la libera fluttuazione del cambio apra a uno scenario di oscillazioni devastanti: Se si applicano delle ragionevoli politiche per la stabilizzazione delle economie nazionali, nulla potrebbe essere più assurdo; di converso, se tali politiche non vengono applicate, non è possibile immaginare alcuna politica della bilancia dei pagamenti sensata per una zona di libero scambio. Se si applicano delle ragionevoli politiche di stabilizzazione interna, rimarranno da aggiustare degli shock esterni, o delle moderate divergenze nella dinamica dei prezzi e dei costi del lavoro. A questo scopo, i tassi di cambio oscilleranno moderatamente in su o in giù; e bisognerebbe incoraggiare in ogni modo lo sviluppo di un libero mercato dei cambi a termine, che minimizzi i problemi causati da queste oscillazioni. (Meade, 1957). A questo si aggiunga che, a fronte di economie “simmetriche” e realmente integrate, la stessa introduzione di una moneta unica risulterebbe superflua, vista la “naturale” convergenza dei tassi di cambio.
La politica del cambio dovrebbe considerare anche il mercato del lavoro, e abbiamo cercato di spiegare il perché: in un’economia sempre più globalizzata, gli shock esterni si possono scaricare o sul cambio, o sui salari. Ne segue che: Solo se si possono definire delle opportune regole di fissazione dei salari i governi europei saranno in grado di utilizzare il proprio potere di controllo sul sistema bancario e sulle politiche di bilancio in modo da combinare il pieno impiego con una sufficiente stabilità, per rassicurare i propri cittadini e gli investitori esteri che non sarà necessario speculare continuamente al ribasso sulla valuta nazionale. […] Il controllo dell’inflazione dal lato del costo del lavoro può essere affrontato solo su base nazionale, perché i sindacati e i meccanismi contrattuali variano enormemente da Paese a Paese [come oggi]. Ci sono sicuramente divergenze di trattamento; e differenze fra paesi europei nella variazione percentuale dei prezzi e dei costi del lavoro, per quanto piccole, possono creare seri problemi di bilancia dei pagamenti accumulandosi negli anni. […] Per questa ragione, se non altro, i tassi di cambio fra le valute europee devono restare variabili, se si desidera evitare l’impiego di restrizioni più o meno permanenti delle importazioni [ossia dazi commerciali] come strumento per compensare divergenze crescenti fra i livelli dei prezzi nei vari Paesi. (Meade, 1957)
E’ quindi fondamentale supportare la reintroduzione della flessibilità del tasso di cambio tra le diverse valute nazionali con l’adozione parallela di politiche di stabilizzazione interna:
- adottare uno standard europeo di salario minimo garantito, differenziato per Paese, ma definito secondo comuni regole europee (Hein, 2012);
- parametrare la crescita dei salari a quella della produttività (Sapir, 2011b), eventualmente legando alla produttività la crescita del salario reale minimo (cioè delle retribuzioni minime garantite corrette per il costo della vita) e prevedendo ulteriori aumenti per i Paesi in surplus commerciale. Oppure, in modo forse più trasparente, determinare la crescita delle retribuzioni nominali sommando alla crescita della produttività quella di un comune obiettivo di inflazione concordato fra i Paesi dell’area (non certo il funesto «2% or less» della BCE);
- programmare la spesa pubblica in modo tale che il deficit pubblico, dato l’ammontare della tassazione, compensi il surplus privato (la differenza fra risparmio e investimento privato), assicurando così l’equilibrio del saldo delle partite correnti (Hein, 2012) e una crescita compatibile con l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.
Naturalmente non avrebbe senso proporre nuove forme di coordinamento in un contesto (quello dell’euro) nel quale l’esigenza stessa di coordinamento, sancita dai Trattati, avrebbe già potuto attuarsi nelle forme consuete, se solo ci fosse stata la volontà politica. Dentro l’euro non ci può essere coordinamento, perché l’euro è il moderno gold standard, intrinsecamente basato sulla LEGGE DEL PIÙ FORTE e sulla SVALUTAZIONE INTERNA, cioè sulla repressione delle classi subalterne e della stessa democrazia. Ma la Storia non si arresta di fronte al delirio di élites ormai remote dalla realtà: se diffondiamo consapevolezza dei reali problemi e ci riappropriamo della nostra dignità di cittadini, L’ITALIA PUÒ FARCELA.
Dott. Matteo Fulgenzi
BIBLIOGRAFIA:
Acocella N., Elementi di politica economica, Carocci editore, 2009
Alesina A., Giavazzi F., La crisi. Può la politica salvare il mondo?, Il Saggiatore, 2008
Bagnai A., Il tramonto dell’euro. Come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur, 2012
Bagnai A., L’Italia può farcela. Equità, flessibilità e democrazia. Strategie per vivere nella globalizzazione, ed. Il Saggiatore, 2014
Barra Caracciolo L., Euro e (o?) democrazia costituzionale, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2013
Huxley A., Ritorno al mondo nuovo (1958), Mondadori, 2016
Krugman P., End This Depression Now!, W.W. Norton&Company, 2012
Lops V., La Germania da 8 anni ha un surplus eccessivo nell’import-export, si rischia «l’eutanasia dell’euro», http://www.ilsole24ore.com, 19/01/2014
Meade J., The Theory of International Economic Policy: II. Trade and Welfare, Oxford University Press, 1955
Monti M., Rampini F. (a cura di), Intervista sull’Italia in Europa, Laterza, 1998
Mundell, R., The European Monetary System 50 years after Bretton Woods: A Comparison Between Two Systems, Monte dei Paschi di Siena, 1997
Obstfeld M., Krugman P., International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, 1997
Savona P., Heisbourg F., La fine del sogno europeo (La fin du rêve européen), les essais Stock, 2014
FONTI INTERNET:
goofynomics.blogspot.com – blog di Alberto Bagnai
orizzonte48.blogspot.com – blog di Luciano Barra Caracciolo
sinistranoeuro.wordpress.com
twitter.com/pdnetwork – account Twitter del Partito Democratico
www.asimmetrie.org – Associazione Italiana per lo Studio delle Asimmetrie Economiche
www.ilsole24ore.com
www.libreidee.org

Casa Editrice “Il Saggiatore”, 2014